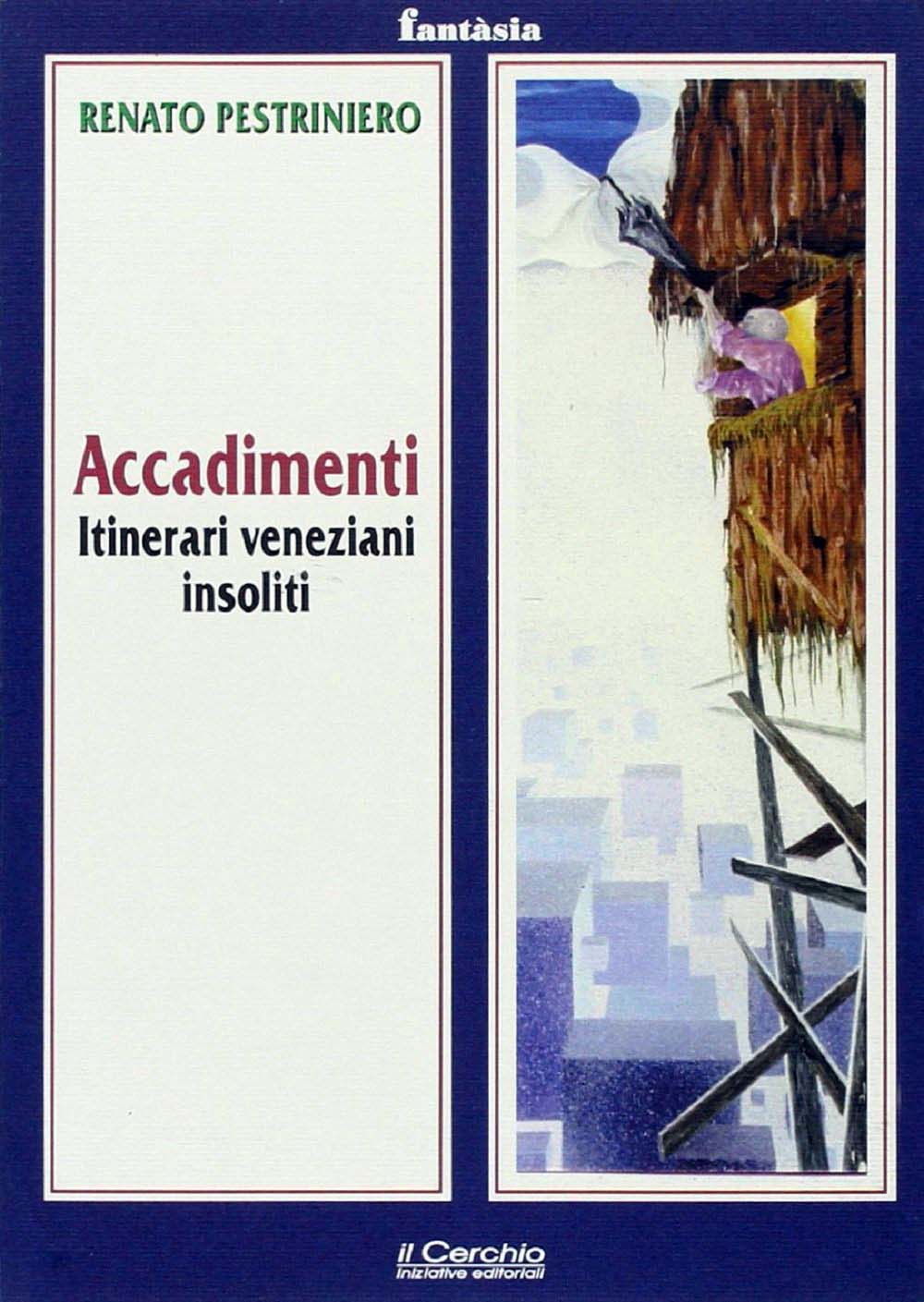 Sono stato a lungo incerto nel presentare questo bellissimo racconto di Renato Pestriniero nell’ambito in cui (invece) alla fine lo trovate: vale a dire su una pagina on line!
Sono stato a lungo incerto nel presentare questo bellissimo racconto di Renato Pestriniero nell’ambito in cui (invece) alla fine lo trovate: vale a dire su una pagina on line!
Inutile dirlo, il racconto è piuttosto lungo per un pubblico che si aspetterebbe brevi resoconti, poi ci sono altri aspetti da considerare. Per esempio non è un racconto di fantascienza tradizionale. Mi ha fatto pensare, fin dalla prima frase, a un racconto gotico ottocentesco. Sembra di entrare nelle atmosfere di Edgar Allan Poe e infatti questo è probabilmente ciò che Renato ha voluto trasmetterci. Renato Pestriniero ci trasporta in questa magia lagunare, che è tutto meno che dolce.
 Ci dice infine Renato Pestriniero che Ci sono segnali è apparso in “Accadimenti – Itinerari veneziani insoliti” antologia personale, Il cerchio, Rimini,2000, e in Robot n°2, autunno 2003.
Ci dice infine Renato Pestriniero che Ci sono segnali è apparso in “Accadimenti – Itinerari veneziani insoliti” antologia personale, Il cerchio, Rimini,2000, e in Robot n°2, autunno 2003.
Buona lettura.
F.G.
A tratti, i due marmocchi smettono di dimenarsi e si bloccano a guardare chi è seduto dietro di loro – cioè Ianù, io e lo sconosciuto – con la sfacciata fissità di cui solo i bambini sono capaci. Chissà cosa sta vorticando dietro quegli occhi, semplici sfiatatoi di menti ancora intonse di freni inibitori.
Quelle due piccole presenze mi infastidiscono, rendono ancora più opprimente l’ultimo tratto di viaggio. La confortevole potenza della Volvo che ci ha portati fino a Venezia riusciva a mitigare il mio disappunto per la decisione di Ianù, nella macchina c’era una forza che lavorava per me, bastava un semplice gesto per adattare spazio e tempo alle mie esigenze. Ma poi, saliti a bordo di questo mezzo lagunare che procede con una lentezza esasperante sulla quale non posso intervenire, mi sento in trappola. Anche se, devo ammetterlo, non userei artifizi di nessun genere per anticipare l’arrivo al luogo dove siamo diretti, ambiguo e per nome e per natura. Lido è nome comune ma in questo caso anche toponimo. Si tratta di striscia di terra lunga e stretta tra due vastità d’acqua che si trasforma in infernale carnaio di corpi e coacervo di macchine in alta stagione, in landa silenziosa con sbavature di nebbia durante la stagione morta.
I due bambini di fronte a me intuiscono il mio stato d’animo grazie al potere istintuale che li guida. Nei loro occhi chiari la fissità diventa morbosa. Vorrei schiaffeggiare quelle guance paffute ipernutrite, rendere gonfi di lacrime quegli occhi inquisitori.
Guardo il panorama attraverso il finestrino, oltre il profilo di Ianù. Siamo nel tratto prospiciente una delle bocche di porto. L’aria della sera ormai inoltrata entra da qualche finestrino aperto portando umidità, soffi di autunno avanzato, odori salmastri e di decomposizione. Li conosco questi odori. Ianù e Fosca hanno voluto fare a piedi il percorso da Piazzale Roma, dove abbiamo parcheggiato la Volvo, fino a San Marco. Per vedere la famosa Venezia, hanno detto. Anzi, per farla vedere a me, loro già la conoscevano. Perché Venezia è città che almeno una volta nella vita bisogna vedere, hanno detto. Sono rimasto nauseato. Palazzi, canali e tutto il corollario di decadentismo inflazionato da miliardi di immagini mi hanno dato solo la sensazione di trovarmi prigioniero di un’arrogante strategia finanziaria manovrata da politici e bottegai.
Il finestrino inquadra il profilo di Ianù sbiancato dal neon. È una luce sporca per i cumuli di chironomidi morti depositati all’interno delle vagine di plastica che racchiudono i tubi lattescenti. Proprio sull’angolo alto del finestrino c’è una mezzaluna che fa schifo tanto sembra falsa. Manca solo il pierrot a cavalcioni, con mandolino e lacrima pendente sul ciglio.
Ianù sta guardando dritto davanti a sé, immobile. Significa che è perduta in luoghi accessibili solo a lei. Indossa tailleur, camicia bianca con collo alla coreana e cappello a tesa dritta. Tailleur e cappello sono color piombo. Lei sa che questa mise le dona molto, mette in risalto la finezza del collo. Gli occhi, già enormi, viepiù dilatati dal trucco fumé, risaltano per l’incredibile ceruleo ametista, mai visto in altra donna. Nemmeno Fosca, malgrado i suoi occhi siano causa di incantamenti, riesce a insidiare Ianù.
 Oggi Ianù ha voluto raccogliere i lunghi capelli neri in un’unica treccia pesante che lascia cadere sulla schiena, dando così pieno campo ai lineamenti del volto. Come poter spiegare a parole il suo aspetto? Forse la definizione più semplice e pertinente sta in un vago ossimoro: completezza nell’essenzialità. Perché, per arrivare all’essenza, è necessario eliminare componenti esse stesse porzioni di bellezza. In Ianù c’è l’essenza, completa però della bellezza nella sua totalità più sfumata. Gli occhi, la linea sottile del naso, le labbra leggere ma, per ragioni inspiegabili, deliziosamente carnose, la modellatura del mento, il disegno pronunciato degli zigomi indispensabile per creare il gioco di volumi, chiaroscuri, sinuosità… Il corpo, anche se splendido, non ha rilevanza, è il volto a esercitare il primo irresistibile atto di seduzione.
Oggi Ianù ha voluto raccogliere i lunghi capelli neri in un’unica treccia pesante che lascia cadere sulla schiena, dando così pieno campo ai lineamenti del volto. Come poter spiegare a parole il suo aspetto? Forse la definizione più semplice e pertinente sta in un vago ossimoro: completezza nell’essenzialità. Perché, per arrivare all’essenza, è necessario eliminare componenti esse stesse porzioni di bellezza. In Ianù c’è l’essenza, completa però della bellezza nella sua totalità più sfumata. Gli occhi, la linea sottile del naso, le labbra leggere ma, per ragioni inspiegabili, deliziosamente carnose, la modellatura del mento, il disegno pronunciato degli zigomi indispensabile per creare il gioco di volumi, chiaroscuri, sinuosità… Il corpo, anche se splendido, non ha rilevanza, è il volto a esercitare il primo irresistibile atto di seduzione.
Ianù ha trentasette anni ed è mia madre. Ianù è il diminutivo di Ianuaria. Io mi chiamo Anzio. Tra due giorni sarò maggiorenne. Fosca è mia sorella. Ha due anni più di me. Mio padre non l’ho mai conosciuto. All’inizio mi avevano detto che era morto quando avevo qualche mese, poi, col tempo, ho saputo che non è vero.
Chissà perché, è stato deciso di festeggiare il mio diciottesimo compleanno nella villa di Elviera, la sorella di Ianù. Anche zia Elviera praticamente non l’ho mai conosciuta. Quando avevo sei anni rimase da noi per qualche giorno. Ho un ricordo vago di donna che non rideva mai. Poi non ho più avuto occasione di incontrarla. La rivedrò quando per la prima volta metterò piede su questo strano luogo chiamato Lido.
La gente si alza per prepararsi a scendere. I due bambini hanno ripreso a litigare tra loro riempiendo la cabina del vaporetto con piagnistei e grida stridule. Malgrado ciò non smettono di lanciarmi occhiate improvvise, quasi a dimostrare che non mi hanno dimenticato. La loro giovane mamma continua a masticare gomma. Dopo un rimescolio di labbra, fa uscire dalla bocca una grossa bolla rosa. La bolla si espande, diventa sottile e trasparente. I due bambini guardano affascinati il volto deformato della donna. Attraverso la trasparenza si intravedono le labbra dischiuse come una ventosa mentre alimentano la bolla di fiato. Una rete di venature si dilata sulla superficie rosata aumentando la parvenza di qualcosa orrendamente organico. Uno dei due bambini protende la mano e artiglia la bolla che, con uno schiocco molle, si affloscia sulle labbra e sul mento. La donna ride a bocca aperta guardandosi intorno, vuole partecipare anche i vicini della sua garrula cura materna. Poi recupera con la punta della lingua le frange di gomma.
Provo un senso di ripulsione verso quella faccia tonda arrossata dal riso e dal trucco, costantemente invasa da onde di capelli arricciati ributtati all’indietro con ritmici scatti della testa. Ma, con sorpresa, la ripulsione si mescola ambiguamente al desiderio di voler fare anch’io come il bambino, di impiastricciarmi le mani in quella bolla rosa di materia masticata, di penetrarla nel massimo del suo turgore fino ad arrivare alle labbra accrespate intorno a un foro buio, e anch’io lacerare e invadere…
Gli occhi dei due bambini mi fissano.
Il mio vicino si alza. Mi alzo anch’io.
La giovane mamma cerca di raggrumare i due bambini. L’uomo gira la testa per guardare dietro di sé. È un naso con un po’ di viso intorno. L’enorme protuberanza ha un sottofondo violaceo, i pori della pelle sono talmente dilatati da dare alla carne l’aspetto granuloso di una colonia di microrganismi. Canticchia un motivo che riconosco. È una canzone sentita recentemente in una trasmissione TV che riproponeva successi degli anni Venti e Trenta… vieni, c’è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu…
Procediamo tutti a piccoli passi. Mi trovo a osservare chi mi circonda con il timore di scorgere caratteristiche particolari in ogni passeggero che si appresta a scendere in questa lingua di terra stesa tra mare e lagune. Indago tra nuche nude, schiene aggobbite, mezzi profili che fanno intravedere menti pelosi, denti gialli rivelati da sbadigli impronti, nasi di vecchi lucidi di muco, mascelle che ruminano, rughe, bistro, nei, gorgiere di pelle flaccida, macchie, brufoli…
Mi rifugio nella ritmata verticalità della treccia di Ianù, nel profilo del suo volto deciso, pulito, perfetto.
Anche la villa di Elvy, benché abitata, non è di facile rintraccio. Il taxi che ci ha portati fino al cancello di ferro battuto ha lasciato la strada principale per ramingare in una rete di vialetti bui, deserti, fiancheggiati da molto verde. Abbiamo costeggiato per lungo tratto un canale di acqua immota, quindi l’abbiamo abbandonato per poi riaccostarlo fino alla villa. Un lato della costruzione cade a piombo sul canale. Il cancello si trova sul lato opposto. Per arrivare al portone interno della villa bisogna attraversare un parco che, nel buio, dà una sensazione di foresta.
A mano a mano che penetro questo angolo veneziano, la sua ambiguità aumenta. Per esempio nessuno penserebbe di trovarsi in luogo balneare se portato in questa villa a sua insaputa. Come non potrebbe pensare, se dovesse svegliarsi per magia in questo letto, di non trovarsi in un canto di costruzione medievale, forse in Inghilterra o Scozia, con queste pareti di pietra che lo circondano, ornate di ferro battuto e candelabri e massiccio legno scuro. Per non parlare del baldacchino. Già, perché il letto sul quale sono disteso è fornito di baldacchino. E, malgrado ciò, le lagune di Venezia sono a meno di un chilometro in linea d’aria.
Zia Elvy la ricordavo diversa. È donna alta e asciutta, le labbra spesso adagiate su un’ombra di sorriso. L’unico lontano ricordo che avevo di lei me la presentava come una figura severa, dall’espressione accusatrice. Ma a quell’età è facile trasformare in orco chi non ti vezzeggia e si limita a guardarti e parlarti senza moine. In realtà Elvy è donna di grande fascino, che avvince per tratto e scelta delle parole, per cui anche argomenti di assoluta normalità si vestono di un interesse particolare. Malgrado i lineamenti del volto non raggiungano l’inquietante armonia della sorella minore, si scorge subito che è sorella di Ianù per qualcosa che colma la dissimiglianza e la sostituisce, e che mette in imbarazzo chi puntigliosamente volesse fare un confronto. I capelli di Elvy sono tagliati a caschetto, neri come quelli di Ianù ma con qualche nuance argentea, credo naturale.
Al primo incontro, avvenuto alla luce del lampione dell’entrata, i suoi occhi mi sono sembrati grigio perla. Più tardi, durante la cena e, più tardi ancora, seduti sulle poltrone accanto a un grande camino spento ma che durante la stagione fredda rappresenta l’unica fonte di calore nel soggiorno, e poi ancora mentre mi mostrava questa stanza, ho visto quel colore cangiare a seconda se la luce veniva filtrata da vetri di Murano o proveniva da spot alogeni nell’office, o era quella delle candele steariche che adesso affollano di ombre la mia camera da letto; in quegli occhi ho scorto allora anche del verde e striature di azzurro intenso, e a volte tanta profondità da far ricordare il nero.
Elvy si è accorta subito del fascino che esercita su di me. Comunque il suo atteggiamento non è quello di donna che usa il proprio corpo come arma o per giocare con i sentimenti altrui, e nemmeno come strumento per procurarsi il semplice piacere di essere ammirata. Quindi non un gesto né una parola vengono manipolati in questo senso, tutto rimane dentro i limiti della più familiare normalità. Eppure, proprio questa normalità agisce nei miei confronti come sottile seduzione. Sono arrivato a concludere che il grande fascino di Elvy sta proprio nello scatenare, attraverso un comportamento di estrema nonchalance, un’attrazione anomala.
Da quale ceppo possono essere uscite creature come Elvy e Ianù? Per quanto riguarda Ianù me lo sono chiesto molte volte. Da questa sera la stessa domanda me la pongo, con ansietà imprevista, anche per Elvy. La storia della mia famiglia è circondata da un alone, se non proprio di mistero, di prudenza, quasi di pudore. Quando chiedevo notizie dei nonni le risposte erano metodicamente vaghe, e c’era sempre qualcosa che mi distraeva, o veniva usato per distrarmi. Più tardi, arrivato all’età in cui l’interesse ha motivazioni più concrete, la diplomazia usata nel fornirmi dettagli di poca o nessuna significanza mi fece capire che insistere sarebbe stato indiscreto.
Per mio padre era diverso, le risposte dovevano essere meno evasive. Un giorno, all’improvviso, mi resi conto di non aver mai visto una fotografia o un film dove apparissero nonni e genitori. E allora venni a sapere che la scomparsa di mio padre, poco dopo la mia nascita, non era stata causata dalla morte come mi era stato detto ma da un male che lo aveva emarginato sia nel mondo materiale che in quello della mente. Però, quando veniva toccato questo argomento, l’imbarazzo era sempre palpabile. Il tempo, la mancanza di documentazione, di indizi e di ricordi trasformarono mio padre in una sorta di fantasma che avesse attraversato per un momento la vita di Ianù e fosse scomparso. Di lui non è rimasto nulla, nemmeno il suo nome. Il patronimico di Ianuaria è Demarchi, il mio nome è Anzio Demarchi. Nelle mie vene scorre il sangue di un fantasma. Solo in un paio di occasioni Ianù si è lasciata sfuggire un nome: Blanco.
Anche nelle vene di Fosca scorre lo stesso sangue, ma lei non è tipo che si soffermi su questi aspetti. Fosca non ha mai indagato o posto domande o sentito la necessità di chiarimenti, non ha mai dato nemmeno segno di soffrire psicologicamente per la mancanza di un padre. La vita di Fosca è sempre stata quella di una ragazza estroversa, decisa. La invidio per questo. Vorrei avere io la sua determinazione, la sua tagliente aggressività nell’esprimersi e nel comportarsi anche quand’è coinvolta in situazioni in cui è chiaramente lei ad aver torto. Alla fine riesce sempre a spuntarla e a vincere, e ne ride. Questa sera, per esempio, quando siamo arrivati alla villa, il tassista ha detto la cifra da pagare. Io stavo per prendere il portafogli ma è intervenuta lei. So quanto le piacciono queste manifestazioni plateali di indipendenza, così Ianù e io ci siamo avviati verso il cancello della villa ché già Elvy stava venendoci incontro attraverso il folto del parco, mentre frasi concitate si intrecciavano tra Fosca e il tassista. Più tardi, quando le ho chiesto se c’era stato qualche problema, lei ha sorriso: – Non mi andava di pagare.
– E il tassista era d’accordo?
– Si è dovuto accontentare di una mancia. Ci ha fatto fare un percorso dieci volte maggiore.
– Ma non è vero! Avete sempre detto che la villa si trova lontana da…
– Oh, Anzio, quanto sei noioso.
Ianù non ha detto verbo. Questa sera il giochetto di Fosca mi ha irritato perché era presente Elvy, anche se la sua reazione non è stata diversa da quella di Ianù, anzi, si è limitata a far sorridere quei suoi occhi cangianti quasi per esprimere compiacimento.
Intanto la falce di luna senza pierrot se n’è andata dal riquadro della finestra. Non riesco ad addormentarmi. Mi alzo e apro la finestra. Sono quasi le due. Non si sente un rumore, solo una specie di brusio. Dev’essere il mare contro i murazzi. Elvy ha detto che appena si alza un po’ di vento le onde provocano un rumore insolito per chi non è abituato. Credo che quando farà giorno andrò a vederli questi famosi murazzi, questo pezzo di Serenissima Repubblica. Mi sarebbe piaciuto andarci insieme a Lavinia, la mia ragazza, ma lei non ne ha voluto sapere di venire a Lido. Pauli invece, l’attuale compagno di Fosca, ha suonato il campanello poco prima di mezzanotte.
Elvy contava di vedere anche loro. – Dove sono gli altri ragazzi? – Ha chiesto appena ha saputo che eravamo soli. – Su, chiamateli, ché possano partire subito ed essere qui già stanotte, o domattina al più tardi.
Ovviamente a Fosca erano bastate due parole perché Pauli si mettesse subito in viaggio. Ma io non sono Fosca, e nemmeno duecento parole sono state sufficienti per convincere Lavinia.
I rapporti mantenuti all’interno della nostra famiglia possono sembrare eccentrici, siamo in tre e ognuno segue le proprie abitudini, i propri interessi. Lo dimostra il fatto che io incontri zia Elvy, praticamente per la prima volta, a diciott’anni. Ecco perché questa programmata riunione famigliare la considero un graffio nell’ottica del nostro ménage. Non che l’invito in sé mi risulti sgradito, è il luogo che mi disturba. Avrei potuto semplicemente rifiutare ma, chissà perché, ha insistito anche Fosca lusingandomi con la promessa che mi avrebbe lasciato guidare la Volvo.
L’aria della notte è umida. Richiudo la finestra e mi rimetto a letto. Sento intorno a me la presenza di decine di stanze vuote che non ho mai viste ma che immagino vuote perché Elvy abita da sola. Sembra non sia mai stata sposata né mai sia vissuta con un uomo. Ora che l’ho vista mi chiedo come può una donna splendida come lei vivere una vita da sola.
Nel punto in cui il lungomare viene interrotto dalla struttura agghiacciante di un bar ormai chiuso comincia una zona cespugliosa. È lì dove bisogna inoltrarsi, si scosta il viluppo di verde e appare il sentiero, una fettuccia di terra e sabbia costeggiata d’erba, sterpaglia e immondizia. Ho proseguito per alcuni metri, chino, all’interno di una galleria formata da arbusti di pittosporo. E subito si è fatta risentire la sensazione di ambiguità: da sinistra arrivava il fragore delle onde, da destra filtravano, attraverso folte macchie di vegetazione, i rumori di un normale traffico cittadino. Ho continuato ad avanzare lungo quella traccia di sentiero che spontaneamente mi è venuto di definire vaga, non tanto come attributo alla sua natura pittoresca quanto come linea di indistinzione tra realtà contrastanti.
All’interno della galleria di vegetazione il suono delle onde si faceva sempre più rabbioso fino a soffocare il rumore del traffico. Sono stato attratto da una scatola di cartone addossata al tronco di un albero morto. All’interno c’erano stracci e due coppe di plastica per gelato, vuote. Gli stracci erano i resti di un gatto. Parte della testa era già ridotta a teschio, spolpata dai topi. La carcassa dell’animale appariva devastata, la pelliccia si afflosciava su poche ossa facendo intuire uno scheletro ormai svuotato di organi. Adesso era tempo di banchetto per animali più piccoli dei topi. Una ventina di mosche dai riflessi verdi si spostavano da un punto all’altro, sostavano, immergevano la proboscide per succhiare i pochi umori rimasti. Poi la pelliccia del gatto ha avuto un fremito e dalla gabbia di ossa è scaturito qualcosa nerolucente che, zampettando, si è immerso nella vegetazione.
Intanto il mare che si frangeva sui murazzi ancora invisibili mi chiamava con urgenza, e finalmente sono sfociato all’aperto. Ma subito mi sono accorto che avevo percorso solo un tratto della striscia vaga poiché, oltre uno spiazzo livellato e privo di vegetazione, essa si rituffava nella macchia. Lo spiazzo era costituito da una lastra di cemento arrotondata ai bordi, con tracce di tondino di ferro arrugginito. In quel manufatto ho individuato il tetto di un bunker dell’ultima guerra, ormai quasi del tutto fagocitato dalla vegetazione e dalla sabbia. Il sentiero riprendeva subito dopo all’interno della fratta e infine si sgranava libero fino a terminare in un punto ingrigito dalla foschia.
Il vento si è irrobustito. Le onde si schiantano e scrosciano sulla pietra con rombare echeggiante. Il vento da est sta accumulando strati di nuvole che lentamente coprono l’azzurro. Fa anche freddo. Il paesaggio che adesso mi circonda è del tutto nuovo, in un attimo sono passato da un’atmosfera soffocante e vagamente di morte a una manifestazione di vitalità naturale. L’Adriatico si stende alla mia sinistra fino a incontrare il cielo. Le sagome delle navi alla fonda creano un falso orizzonte. Alle spalle dei blocchi che servono per frantumare le onde c’è una fascia larga una ventina di metri composta di massi livellati, una sorta di pavimentazione che in prospettiva appare come la superficie di un deserto pietrificato. Alcuni massi rozzamente squadrati si alzano come menhir piantati da giganti, e la loro presenza inserita in un paesaggio di dimensioni colossali, sfumato dall’acqua nebulizzata delle onde, aumenta un senso di primordialità che mi eccita.
La pavimentazione si eleva con rapida inclinazione fino a un terrapieno alla cui sommità corre una strada che fiancheggia l’intera estensione dei murazzi. Il percorso è riparato sul lato a mare da un muretto che lo trasforma in un camminamento incastrato tra esso e l’intrico di piante selvatiche sul lato opposto.
Ho qualche perplessità prima di inoltrarmi lungo questa via straordinaria. Sono completamente solo. Non vedo altre presenze fin dove muretto e barriera vegetale si congiungono nella prospettiva in un unico punto. Il solo movimento è dato dalle onde e dal flemmatico volo dei gabbiani. Più mi inoltrerò più mi troverò isolato tra il mare e questa vegetazione che a tratti deborda e invade l’esiguo spazio del camminamento.
Ho oltrepassato da poco un viottolo che scivola giù dalla scarpata e, prima di scomparire nel folto, viene interrotto da una porta. Quale funzione può avere una porta in questo contesto?
Il cielo è ormai un filtro grigio che dà agli oggetti una dominante plumbea. Il muretto viene interrotto all’improvviso da una fessura appena sufficiente per far passare una persona. Sedici gradini scolpiti nella scarpata di pietra portano alla strada di massi livellati. Mentre sto valutando l’opportunità di scendere per poter raggiungere la barriera di massi proprio dove le onde si infrangono, un movimento attira la mia attenzione. Una lucertola mi osserva dalla sommità del muretto. Mi trovo ad avere la mano chiusa a coppa sul corpo del piccolo rettile. Lo sento dibattersi tra la rugosità del cemento e la morbidezza del mio palmo. Chiudo la mano a pugno. Il muso triangolare preme tra medio e indice. Allento un po’ la presa. Subito l’animale tenta di sgusciare fuori ma stringo le dita e la lucertola non ha più scampo. Dal mio pugno escono la testa, il collo e una zampa che spinge affannosamente per liberare il resto del corpo. Gli occhi della lucertola sono sbarrati, la sua gola pulsa, il ventre molle freme. Stringo di più il pugno. Nella mia mano c’è adesso qualcosa di morbido che si conforma alle pieghe delle dita. Il muso antico si solleva, la bocca spalancata nell’agonia, la lingua che saetta, le dita prensili si stirano, tutto ciò che della lucertola può ancora avere libertà di movimento esprime terrore e spasimo. Nel silenzio. Poi, dalla bocca spalancata esce una sostanza liquida, vischiosa. Lascio cadere il piccolo corpo schiacciato. Mi guardo la mano bagnata dove sono rimasti appiccicati frammenti di organi. Mi pulisco con un kleenex. Sento che un groppo sta gonfiandosi dentro di me non solo per aver ucciso quel minuscolo animale ma per come l’ho ucciso. Il groppo si allarga e mi impedisce di staccare gli occhi dalla mano. Rivedo questa stessa mano quando apparteneva a un bambino di pochi anni. Quella volta non ho usato un kleenex, mi sono pulito semplicemente sul vestitino. Un fatto dimenticato e poi, evidentemente, rimosso. Non è facile essere più veloci di una lucertola, specialmente per un bambino di pochi anni.
Continuo a guardare questa mano che, indipendentemente dalla mia volontà, ha catturato un animale saltando una frazione temporale. Perché ricordo di aver sollevato la mano ma non ricordo di aver girato il braccio per portarla sopra la lucertola e infine di averla calata sul suo corpo. Non ricordo nemmeno il contatto con il muretto.
Respiro a fondo per attutire il pulsare che mi riempie il petto. Quanto mi circonda ha assunto un aspetto diverso ma so che in realtà tutto è rimasto immutato, sono io a sentire diversamente.
Il camminamento si prolunga davanti a me assottigliandosi fino a quell’unico punto sfocato nel grigio. A un centinaio di metri c’è uno squarcio nell’intrico di piante selvatiche. Molto più lontano, una costruzione alta e stretta si eleva dalla boscaglia. Vorrei arrivare fin laggiù prima di tornare alla villa ad annoiarmi. Domani è il mio compleanno. Dopodomani, finalmente, tutto tornerà normale. Mi è sempre più oscura la ragione che ha spinto Ianù a venire in questo luogo. È deprimente. La schizofrenia che lo pervade mi angoscia, eppure, malgrado tutto, ne sono attratto. Probabilmente non avrei tante fisime se Lavinia fosse qui. Sì, credo proprio che dipenda dalla mancanza di Lavinia, sarebbe entusiasmante poterla avere qui, stesa sopra questi massi, con gli spruzzi delle onde che… Il ricordo del suo corpo mi eccita. La immagino nuda sul letto a baldacchino, nella torre, con la curva parete di pietra. Sorrido. Andrà a finire che tornerò qui di mia volontà. Con Lavinia, naturalmente.
Il cielo promette pioggia. Aumento il ritmo per raggiungere al più presto lo squarcio nella vegetazione. Non è che un’altra piattaforma grigia, un altro bunker. È probabile che tutto il litorale sia disseminato di casematte ormai sepolte tra cespugli e roveti.
Salgo sulla costruzione. Sporgendomi dal lato opposto riesco a vedere che si tratta di un blocco a forma di T alto circa quattro metri. La vegetazione intorno non è molto folta e mi permette di scorgere l’entrata in un angolo tra le due barre della T. Lo spessore delle pareti è di almeno un metro. La porta consiste in una lastra di ferro con movimento su binario, rimasta bloccata prima di chiudersi del tutto. Ovviamente adesso è solo una massa di ferro arrugginito.
Sul tetto del bunker ci sono quattro fori di una decina di centimetri di diametro. Forse si tratta di sfiatatoi. Due di essi sono occlusi da sterpi, terra e sabbia. Gli altri due sembrano liberi. Guardo all’interno ma vedo solo buio. Stacco una lunga canna dal bordo del camminamento e l’introduco nei fori. Nel primo essa penetra per una ventina di centimetri, poi incontra un ostacolo. Nel secondo foro la canna penetra per l’intera lunghezza senza peraltro toccare il fondo. Da quell’osservatorio potrei farmi un’idea dell’interno. Mi chino sull’apertura facendo schermo con le mani intorno agli occhi, ma continuo a vedere solo buio. Il bunker è circondato da pozzanghere fangose, sterpi, rifiuti di ogni genere. Sul lato a mare, nello spazio tra parete e camminamento, esce dal terreno l’estremità di un corpo cilindrico. Sembra la parte terminale di una tubazione, forse appartiene alla struttura del bunker. Dall’orificio trasuda un odore di putrefazione, ma temo che il giudizio sia condizionato dall’ambiente. Il terreno dove sorge il bunker si estende verso l’interno per qualche centinaio di metri, è probabile che arrivi alla periferia dell’abitato. A causa delle numerose pozze d’acqua che tingono il bruno del terreno con il grigio perla del cielo, la zona ha l’aspetto di un acquitrino. Individuo un altro bunker. Sulla sua sommità è cresciuta una vegetazione rigogliosa. Alcuni rami escono anche dalla feritoia che corre lungo un intero lato a circa un metro dal tetto. I rami sono grossi, nodosi, senz’altro figliati da tronchi massicci. Mi soffermo a immaginare quale tipo di vegetazione può essersi sviluppata all’interno di queste costruzioni. Anche dalla fanghiglia intorno a quel bunker escono le parti terminali di tubi. Forse esiste una rete di tubazioni che collega l’intero complesso di casematte, e anche passaggi sotterranei previsti per lo spostamento di soldati, per i rifornimenti di munizioni e vettovaglie.
Torno sul camminamento. Le prime gocce di pioggia dovrebbero cadere da un momento all’altro ma voglio prima arrivare a quella strana costruzione alta e sottile che si alza dalla boscaglia.
A un duecento metri avanti a me vedo finalmente un altro essere umano. Pare stia facendo jogging. A mano a mano che la distanza diminuisce mi accorgo che quel tipo corre per poche decine di metri, poi torna indietro fino al punto da dove è partito e si ferma, rimane fermo pochi secondi, quindi rifà lo stesso percorso. Indossa una tuta blu elettrico con baluginanti strisce giallo limone. Quando lo raggiungo mi sorride, ansante. È un vecchio. – Bisogna tenersi in allenamento – dice alzando e abbassando le braccia come volesse levarsi in volo. – Pronti per ogni evenienza. – Mi guarda. La sua faccia è stravolta, e non solo per lo sforzo fisico.
– Ha ragione – dico. – Ma quali evenienze intende?
Il vecchio continua a fare ampi gesti con le braccia e non mi stacca gli occhi di dosso. Adesso non sorride più, anzi, sembra quasi ci sia paura nel suo sguardo alterato.
– Ci sono segnali. – Sussurra. Poi, con imprevedibile abilità, si mette a sedere sul muretto. – Tu sei nuovo – aggiunge. – Non ti ho mai visto.
– È la prima volta che vengo qui. Questa era una zona fortificata, ci sono molti bunker.
Il vecchio sposta lo sguardo sulla boscaglia. – Tedeschi. Hanno fatto tutto i tedeschi. Io li ho visti. Ce ne sono ancora lì dentro.
– Di tedeschi?
– Anche di nostri. La guerra non è mica finita. Si è solo trasformata.
Peccato. Speravo di trovare qualcuno in grado di darmi informazioni ma l’unico che bazzica questi luoghi fuori dal mondo è un matto. Indico la costruzione alta e stretta. – È un altro bunker quello laggiù?
Il vecchio scuote vigorosamente la testa. – Nossignore. Quella è la casa dove si radunano per fare le porcherie. Ogni stanza una porcheria. Sono sei stanze una sopra l’altra.
– E cosa sarebbero queste porcherie?
Il vecchio scrolla le spalle. – Tu non sei di qui. Sarebbe troppo lungo spiegare. E poi dovresti chiederlo a Blanco. È lui che sa.
Sento uno strappo dentro di me. – Blanco… chi è?
– Il professore. Però tu non puoi parlare con lui, i dottori non vogliono.
– Perché non vogliono?
– Non lo so, è sempre stato così. Blanco ci racconta solo quando riesce a fregarli e viene nella nostra camerata, di notte. Ma succede raramente. – Il vecchio si guarda intorno. – Sì, molto raramente.
Chiedo ancora: – Lei abita assieme a questo… Blanco. Dove esattamente?
– Laggiù, al Karl Step. Da qua non si vede ma è proprio dietro le piante. Si sta bene lì. Io e qualche altro possiamo anche venire fino ai murazzi per la ginnastica. Siamo in tre che ci alleniamo. Il professore non potrebbe venire manco se lo lasciano. Non perché è vecchio, è più giovane di noi, ma lui può lavorare solo di testa, non di gambe. – Il vecchio scivola giù dal muretto. – Adesso devo tornare. Meglio tornare quando vogliono i dottori così ci lasciano allenare. – Si dirige verso il folto.
– Un momento – dico in fretta. – Mi parli di Blanco… e della torre. Posso accompagnarla fino al… – Mi blocca puntandomi entrambe le mani sul petto. Il suo volto è rosso, mi guarda con occhi dilatati. – Fermo là, ci stanno osservando. Tu non puoi muoverti.
– Quando verrà ancora ad allenarsi?
– Che domande! Domani alla solita ora, no? – Mi fissa. – Vuoi un consiglio? Non cercare di seguirmi, non riusciresti ad attraversare le piante, è pieno di serpenti agricoli. – Si gira di scatto e si immerge nella macchia seguendo un sentiero che non riesco a vedere. Lo sento cantare vieni, c’è una strada nel bosco, il suo nome conosco…
– Quanti anni ha Blanco! – Grido al viluppo di vegetazione che ha inghiottito il vecchio.
– … vuoi conoscerlo tu. Vieni, è la strada del cuore dove nasce l’amore…
Sono sconvolto. Rimango a lungo a guardare nella direzione dove il pazzo è sparito con la speranza di vederlo rispuntare per una decisione improvvisa del suo cervello malato, ma tutto rimane immoto, silenzioso. C’è solo il rumore delle onde che si scagliano sui murazzi. I blocchi di pietra d’Istria luccicano di luce opalescente. Qualcuno ha marchiato un grosso blocco con un cerchio di spray nero. Questo mi fa ricordare che anche un altro masso era marcato con lo stesso spray, una linea verticale. Chissà qual è il significato di quei segni.
Il vecchio ha parlato di sei stanze poste l’una sull’altra. Può essere. La torre è quadrata, alta una trentina di metri, ciascun lato di circa quattro metri. La parete di fronte al mare ha sei finestre, tutte sulla stessa linea verticale. Nessuna finestra sulle due pareti laterali, e nemmeno porte di accesso. Non mi è stato possibile controllare il lato posteriore. Le finestre sono sigillate con imposte di legno verde glauco. Non ci sono tracce di camini o di altre strutture esterne che possano fornire indicazioni di abitabilità. Apparentemente la torre risale all’inizio del secolo scorso, le pietre sono vecchie, scavate dalla salsedine e dal tempo come quelle della villa di Elvy che risale appunto agli inizi dell’Ottocento. Ma è la struttura che non corrisponde, così lineare, squadrata, essenziale. L’unica immagine del suo interno che riesco a concepire è una serie di sei cubi sovrapposti, ognuno con una finestra che guarda il mare, e una scala a chiocciola che li collega attraverso botole.
Fino alla spiaggia di Alberoni non ho trovato nient’altro di particolare salvo qualche altro blocco di pietra marcato con lettere dell’alfabeto, ma questi non sono particolari importanti. Almeno credo. Piuttosto, una caratteristica di questo luogo che poco a poco sta diventando inquietante, è l’assoluta mancanza di vita. Da quando sono sbucato dal tunnel di pittosporo ho incontrato solo il matto. Eppure oltre le sterpaglie e gli acquitrini ci sono le case di Lido, di Metamauco, di Alberoni… però anche i rumori del traffico e delle attività commerciali filtrano con difficoltà, quasi frenate, impedite. Ho ripreso il cammino.
La pioggia leggera non mi disturba, anzi, provo sollievo a fare brevi tratti con il viso alzato e gli occhi chiusi. Ma la strada è lunga e non vorrei trovarmi nel giorno del mio compleanno con un fastidioso raffreddore. L’orizzonte è scomparso, mare e cielo si sono coagulati in un unico grigio. Anche intorno a me i colori sono svaniti, dilavati, c’è solo il bianco sporco delle pietre e il grigio bruno della sterpaglia.
Per questa ragione vengo subito attratto da una manciata di punti colorati. Nell’avvicinarmi vedo con sorpresa che si tratta di tre persone. Indossano leggeri impermeabili di plastica. Questa presenza, altrimenti del tutto normale, mi si presenta come un avvenimento straordinario.
Sono due donne e un uomo. Appena venti metri mi dividono adesso dal gruppo. La mia attenzione è rivolta alle due donne, giovani, una con capelli chiari e ricci che il vento agita sul cappuccio dell’impermeabile blu, l’altra con acconciatura a coda di cavallo dalla quale la luce grigia trae riflessi brunorossastri. Quest’ultima indossa un impermeabile giallo. Sono entrambe sedute su un masso un po’ arretrato, al riparo dagli spruzzi del mare. La loro positura è oltremodo disinvolta. La minigonna che entrambe indossano è costretta a raggrinzirsi sull’inguine, tanto che riesco a scorgere tra le cosce la sottile linea bianca delle mutandine.
La ragazza con l’impermeabile giallo solleva le braccia per sistemare l’acconciatura. Il movimento mette in evidenza un seno prepotente.
– Ehi, Anzio!
Solo a quel richiamo passo lo sguardo sull’uomo. Il ribaltamento della situazione è totale. – Pauli! – Esclamo.
– C’è un passaggio lì. – Mi fa Pauli indicando un punto sul muretto avanti a me. Raggiungo la barriera dei murazzi. Le due ragazze sorridono e non modificano la loro posizione. Da come mi guardano è chiaro che sono perfettamente consapevoli del loro atteggiamento.
– Contavo di incontrarti – dice Pauli. – Ma sinceramente stavo perdendo le speranze. Si può sapere dove sei andato a finire, è da stamattina che non ti si vede.
Guardo l’orologio. Sono quasi le quattro del pomeriggio. Pauli continua: – Qui è un mortorio. Stagione finita, tutto chiuso.
Mi presenta alle due ragazze. Poi, indicandole col pollice: – Mi hanno salvato. Non ci fossero state loro avrei ceduto alla malinconia e mi sarei gettato in mare, mi ha veramente rotto le palle questo posto di merda.
La ragazza bionda si chiama Sala e quella con i capelli a coda di cavallo Ottavia. Sento un gran calore. L’eccitazione provocata dal pensiero di Lavinia è tornata di colpo, esasperata. Non riesco a crederci ma devo trattenermi dal prendere Ottavia, la più vicina, e rovesciarla sulla pietra, sicuro di poter impedire sia alla sua amica che a Pauli di frenare il mio gesto. Qualcosa di imprevedibile si sta sviluppando dentro di me, come se una personalità che non mi appartiene stesse emergendo all’improvviso. Il mio corpo è irrigidito, teso, tutta la mia residua volontà indirizzata a trattenermi, le mani serrate sulla rugosità della pietra. Mi rendo conto che la violenza traspare dal mio sguardo, eppure non provo senso di vergogna o pudore.
È calato un gran silenzio. Perfino la disinvolta loquacità di Pauli si è dissolta. I miei occhi sono fissi sul corpo di Ottavia ma so che Pauli e Sala mi stanno osservando, bloccati dalla sorpresa e dall’incredulità. Anche Ottavia mi fissa però i suoi occhi sorridono. Tiene le labbra leggermente socchiuse, unite da un filo di saliva, le mani dietro la nuca continuano a sistemare l’acconciatura con movimenti inutili. Il suo busto è proteso. Attraverso il leggero tessuto della maglietta, il turgore dei capezzoli è la risposta al messaggio del mio corpo, un messaggio lanciato e subito recepito a livello di animalità pura. Il suo sguardo e il mio scorrono sui nostri corpi, li scrutano li penetrano li succhiano li spremono… Il tempo si è fermato, è il momento della metamorfosi, l’attimo in cui la scorza cade a scaglie, la pelle si rovescia. So che quando il tempo ricomincerà a fluire sarà un tempo nuovo.
Afferro la mano che Ottavia mi offre. L’aiuto ad alzarsi ed entrambi scendiamo dai massi. Lontano, dietro di me, sento la voce di Pauli ma è cosa che non mi riguarda, una voce appartenente al vecchio tempo. Adesso è Ottavia che mi conduce attraverso il tratto pianeggiante e poi lungo la scaletta di pietra fino a riguadagnare il camminamento… o forse sono io a condurre lei… ognuno di noi parla all’altro ma sono soliloqui muti. La strada per arrivare al bunker sembra contrarsi perché la massa di cemento grigio è già a pochi metri di fronte a noi. Il sentiero si forma davanti ai nostri piedi perfettamente visibile nella sua invisibilità, scende fino alla base del bunker. La porta d’acciaio bloccata dalla ruggine sui binari ci lascia passare a fatica.
Un’onda di afrori mi avvolge. Sono cosciente di camminare su escrementi di ogni genere mentre la mano di Ottavia mi conduce oltre l’angolo appena visibile per la luce residua dell’esterno. Indovino sulle superfici di cemento ombre di fumo di candela, disegni di amplessi tra forme che non riesco a identificare seppur vagamente antropomorfe, scritte incomprensibili, brandelli di materia sconosciuta. Poi Ottavia è di fronte a me, le spalle appoggiate alla parete, il corpo inarcato all’infuori. Le sue mani cercano ansiose, quasi una scadenza improrogabile imponga di annullare la normale liturgia. Non possiamo permetterci i pochi attimi per togliere le mutandine e allora basta uno scostamento con due dita ed è lei che sceglie la soluzione. Residui di percezione mi ricordano il lezzo che ci circonda, l’equilibrio instabile mi informa che il fondo del bunker è uno strato di rifiuti accumulatisi in mezzo secolo di buie frequentazioni. Il fetore di putredine è così intenso da dare la vertigine, lo stesso fetore avvertito quando stamane – o era nel pomeriggio? – mi sono avvicinato a uno degli sfiatatoi, ma tutto viene assorbito e si mescola, i confini non esistono più, i parametri di valutazione sono scomparsi, i freni inibitori cacciati dall’istintualità. Respiro i miasmi a bocca spalancata, li spingo con forza in fondo ai polmoni per esserne imbevuto e aiutare l’orgasmo che sento arrivare come una vampa. Il corpo di Ottavia mi asseconda con grande esperienza, c’è una immedesimazione che va al di là della fisicità normale. Vivo contemporaneamente a più livelli percettivi dove dettagli e sensazioni vengono esaltati fino alla soglia dell’insopportabile… probabilmente assieme alle esalazioni inspiro anche sostanze narcotiche… e l’orgasmo arriva e si prolunga… e continua… sembra non avere fine… subentra una sensazione di paura nel constatare che il controllo del mio corpo non ritorna… intuisco cosa significa morire di piacere… e l’onda continua a sommergermi e il corpo di donna che stringo si trasforma plasticamente offrendo sempre nuove fonti alle quali la mia libido trova appagamento. La voce di Ottavia si modifica sotto le sollecitazioni alle quali anche il suo corpo è sottoposto e a volte è lei e a volte è Sala, e la schiena che ora sento sul petto e la soda morbidezza di fianchi e glutei nella quale affondo le dita sono diverse e le mie labbra passano sulla nuca e sui corti capelli a caschetto di Elvy… ma subito, nel cangiare di questo corpo inconoscibile che continuo a possedere mentre si china sotto di me in nuove iniziative, stringo tra le mani una treccia nera ed è quella di Ianù… ma già i singulti e i gemiti scuotono spalle che non sono più di Ianù ma di Lavinia… la mia mente vacilla… sento che mi trovo sull’orlo di qualcosa e che l’unica soluzione per non precipitare è interrompere il meccanismo perverso che non concede fine al mio orgasmo, devo staccare da me questo corpo che lo provoca e lo mantiene, eliminarne la causa… e allora afferro la treccia riapparsa che si scioglie nella vaporosa capigliatura di Sala e tiro a me con tutte le forze rimaste fino a poter passarle il braccio intorno al collo… stringo…
Appena riesco a uscire dal suo corpo trovo subito maggior energia per stringere. Sento i gemiti trasformarsi in rantolo. Stringo più forte ancora. Ho gli orecchi colmi del mio urlo. All’improvviso le sue mani mi afferrano il polso e annullano la stretta. Non riesco a resistere, la sua forza è inaspettata, il suo scatto per liberarsi è l’istinto di conservazione di un animale braccato. Mi trovo con le mani che annaspano nell’oscurità mentre uno spiaccichio di passi si sta allontanando verso l’uscita. Una silhouette vaga viene inquadrata per un attimo dalla fessura contro il lucore proveniente dall’esterno. Poi più nulla.
Respiro a fondo. L’aria mefitica mi fa rivoltare lo stomaco in un’onda improvvisa di vomito. Finalmente arrivo all’aperto. Chiudo gli occhi e respiro a pieni polmoni l’aria pura. I conati si calmano. Il rumore delle onde è il saluto di un amico ritrovato. Solo quando riapro gli occhi mi rendo conto di particolari che prima avevo registrato sotto il livello di coscienza. Già il chiarore che aveva tratto dal buio la figura fuggita attraverso la fessura era una bizzarria. Infatti il cielo è sereno ma è notte, con la solita mezzaluna da cartellone. A poco a poco anche il respiro torna regolare, il ritmo cardiaco perde l’affanno. E allora libero la mente alla consapevolezza che qualcosa di ancora indefinibile è cambiato in me. Provo un senso di libertà… sì, le scaglie sono cadute, la pelle si è rivoltata… mi sento io.
Al chiarore della luna la vegetazione è un insieme di macchie nere, vive solo quando sono percorse dai refoli provenienti dal mare. Non vedo traccia di sentiero. Il rumore delle onde viene da destra ed è in quella direzione che mi muovo. Il camminamento si prolunga davanti a me come una fettuccia grigia che sfuma.
Appena una decina di passi e sento le voci. Mi fermo ad ascoltare. Sono parole incomprensibili, ansimanti, provengono dal folto oltre uno spiazzo libero di vegetazione. Riconosco subito il tetto di un bunker. Dalla bocca di uno sfiatatoio esce uno spolverio di luce. Mi accosto e spio all’interno. La fonte della luce è fuori del mio limitato campo visivo ma il suo tremolio è quello inequivocabile di una candela. Riesco a riconoscere i capelli biondi di Sala. La ragazza è in una strettoia proprio sotto lo sfiatatoio, di certo il passaggio da una stanza all’altra. È seduta su una rientranza nella parete di cemento con i piedi puntati sulla parete di fronte. Tiene le gambe divaricate per accogliere Pauli in piedi di fronte a lei. Pauli la sta penetrando e Sala lo incita con suoni spezzati dall’eccitamento. Osservo curioso. L’esperienza appena vissuta non mi impedisce di sentirmi sicuro di soddisfare anche Sala. Queste mie possibilità sconosciute sono una piacevole sorpresa ma a dare la misura del mio cambiamento sono aspetti ben più sottili e a ben più profondi livelli.
Sto assistendo a un rapporto che non ha nulla in comune con l’aggressività bestiale scaturita dal mio incontro con Ottavia. Vedo Pauli alzare la testa, gli occhi chiusi, quindi abbandonarsi sulla spalla di Sala, il corpo scosso dagli spasmi. Il braccio destro di Sala si alza a circondare le spalle del ragazzo ma la mano è chiusa e nel pugno stringe qualcosa. Il pugno si abbatte sulla schiena di Pauli. Sento l’urlo e vedo il suo corpo inarcarsi. Il pugno di Sala colpisce una seconda volta e poi ancora. Alla luce della candela vedo il coltello che affonda, il sangue che impregna la camicia chiara. Pauli guarda nella mia direzione, la testa arrovesciata, gli occhi sbarrati, il cuore già spaccato. E, incredibilmente, il suo corpo continua a essere scosso dagli spasmi e Sala lo tiene premuto contro di sé per ricevere fin l’ultima stilla. Poi, quando Pauli rimane finalmente immobile, Sala abbandona la stretta e lui cade nella lordura.
Mi ritrovo ritto in piedi a fissare lo sfiatatoio, quel minuscolo cerchio scialbo che mi ha fatto vedere la morte di Pauli come in uno specchio magico. Pauli è stato ammazzato da Sala. Ormai Pauli non esiste più, è un cadavere osceno, un altro rifiuto tra i rifiuti accumulatisi all’interno di questi bunker. Mi rendo conto di essere stato testimone di un fatto spaventoso, eppure provo più inquietudine che dolore. Voglio capire perché. Devo bloccare Sala prima che lasci il bunker e svanisca come Ottavia. Ma mi trovo in una posizione dalla quale non posso agire velocemente, non posso fare un salto di quattro metri nel buio.
Ritorno sul camminamento. Forse il camminamento è anche per Sala l’unica strada. Potrei limitarmi ad aspettarla qui. Ma i minuti passano e non sento rumore. Decido di scendere. Scosto cautamente rami, canne e rovi tastando con il piede il terreno in ripida discesa. Finalmente la macchia si fa rada e intravedo la linea verticale del bunker. Il terreno è una mota nella quale i piedi affondano con risucchi che sembrano lappar di cane. Dall’interno non filtrano né rumori né luce.
Mi affaccio alla porta, un rettangolo nero dai bordi smangiati dalla ruggine e dal tempo. È evidente che Sala si trova già lontano. Faccio scattare l’accendino alto sopra la testa. Pochi passi per attraversare il primo vano e subito sono nella strozzatura che porta alla seconda stanza. Sopra un contenitore vuoto c’è un mozzicone di candela dall’estremità ancora molle. Nell’aria, mischiato al lezzo, c’è il caratteristico odore di lucignolo smorzato. Osservo il soffitto. Ho un’ulteriore conferma che mi trovo sul posto giusto perché il foro dello sfiatatoio è quasi sulla verticale. Mi chiedo come abbia fatto Sala a far scomparire così in fretta e silenziosamente il corpo inerte di un uomo alto un metro e ottanta centimetri e pesante oltre settantacinque chili.
Non capisco ancora per quale ragione questa torre è stata costruita. Non ha nessuna logica dal punto di vista abitativo né da quello civile o bellico o scientifico, non ha impianto idrico, di illuminazione o di riscaldamento, non ci sono tracce di un sistema qualsiasi di comunicazione. Le uniche aperture sul mondo esterno sono queste finestre che ho già viste dal camminamento, una per ciascuna stanza, tutte sulla parete di fronte al mare. L’entrata è sul lato opposto. Ci si arriva facendo un largo giro tra vegetazione e canali per evitare la piccola laguna melmosa dalla quale sorge la torre. Un’asse fa da ponte per collegare l’ultimo lembo di terreno sodo all’entrata.
Adesso mi rimane da salire un’altra scala per arrivare all’ultima stanza, la sesta. Con me ci sono Ianù e Fosca. Se non ci fossero loro non potrei essere qui. Sono loro ad avere le chiavi della torre.
Gli unici rumori sono quelli che provochiamo noi nel passare da una stanza all’altra. Ma è come se noi tre fossimo un’entità unica, c’è un sentimento nuovo che adesso mi unisce a queste due donne, un più profondo senso della famiglia.
A mano a mano che proseguo nel mio viaggio verticale si consolida la sensazione di avvicinarmi a un accadimento per il quale tutti i miei anni sono stati una vigilia. C’è un’epifania nell’aria, mi sento proteso, ansioso di conoscere, di sbloccare un’attesa rimasta per tanti anni nascosta, mascherata da tempo di routine. E allora, nell’immanenza che mi pervade, ogni altra cosa perde valore, la mia attenzione non si attarda per esaminare, per porre domande o anche per meravigliarsi, o indagare ad esempio da dove proviene la luce che riempie ogni stanza con intensità sempre uguale malgrado le finestre siano serrate da pesanti imposte. Anche le domande sulla natura di questa costruzione mi sfiorano appena, incapaci di modificare un solo mio movimento. E la morte di Pauli, alla fine, mi appare un avvenimento secondario. Ha dato il suo contributo. Sono state queste le parole di Ianù quando sono arrivato alla villa a notte inoltrata. E Fosca e Elvy sono rimaste silenziose a guardarmi. Sì, se Pauli è morto significa che così doveva essere. Non ho approfondito la cosa poiché tutto mi sarebbe stato chiaro a tempo debito, anch’io sono un piccolo ingranaggio del grande meccanismo. Nessuno me l’ha detto esplicitamente ma non è necessario, lo so.
E così, dopo aver dato la notizia, mi sono ritirato nella mia camera di pietra, esaurito per lo sforzo fisico al quale non sono avvezzo. Quando mi sono svegliato da un sonno ininterrotto e senza sogni, la luce del sole entrava attraverso la finestra. Ianù, Elvy e Fosca erano già a tavola e mi aspettavano per la colazione.
– Oggi è il compleanno di Anzio. – Ha detto Elvy versando il tè. Ianù mi ha passato la mano sulla nuca. – Questo è un giorno importante per te. – Ha aggiunto. Stamane Ianù era particolarmente bella, i suoi occhi avevano una luce insolita. I capelli non erano più raccolti in un’unica treccia ma lasciati liberi a incorniciare il volto e solo all’altezza delle spalle erano raccolti e stretti da un nastro. Fosca non diceva nulla ma anche in lei stamane c’era qualcosa di diverso, mi eccitava la fusione tra la sua forza, che ben conosco, e la femminilità sconvolgente che traspariva da ogni suo gesto, dal modo di guardare. Osservavo con occhi nuovi le sue mani mentre spalmava il miele sui crostini, le sue labbra mentre sorseggiava il tè.
Di fronte avevo Elvy. Lei indossava una larga vestaglia tenuta chiusa alla vita da una cintura. Il grigio damascato del tessuto metteva in risalto il colore degli occhi. Nel servire il tè la vestaglia si era allentata, il collo sciallato aveva scoperto parte della spalla e il turgore del seno fin quasi all’alone bruno del capezzolo. Elvy era nuda sotto la vestaglia. La sua altera matura noncuranza la rendeva desiderabile in modo quasi doloroso. C’è stato un attimo in cui i nostri sguardi si sono incrociati e siamo rimasti così, immobili, a fissarci per un tempo che, prima, mi avrebbe imbarazzato. Ma ho continuato a fissarla per il semplice motivo che non potevo spostare lo sguardo. Allora il disegno perfetto delle sue labbra si è modificato in un sorriso. – I tuoi diciott’anni. – Ha detto.
Finita la colazione, Ianù si è alzata per prima. – Adesso dobbiamo andare. – E anch’io e Fosca ci siamo alzati. Elvy è rimasta al suo posto, guardava solo me e continuava a sorridere.
Sto per entrare nella sesta stanza. Dietro a me viene Fosca, poi Ianù. Quest’ultima stanza potrebbe essere una qualsiasi delle altre cinque sottostanti se non fosse per il soffitto che si presenta integro e per l’assenza di scala a pioli. Ianù si avvicina alla finestra, apre i vetri, quindi toglie il paletto, spalanca le imposte. Poi si mette di lato per permettere che mi affacci. In un unico colpo d’occhio abbraccio l’intera barriera dei murazzi da Lido fino ad Alberoni. Riconosco perfettamente tutti i luoghi e i particolari. I bunker si distinguono agevolmente tra la vegetazione. Lontano sulla sinistra vedo una figura blu elettrico a strisce gialle che percorre a passo di corsa un tratto di camminamento, si ferma, torna indietro. Nient’altro si muove se non i gabbiani nei loro instancabili giochi con il vento, e le onde che da quassù appaiono come un orlo bianco del mare. Spingo lo sguardo in direzione di Alberoni. Proprio all’estremità del campo visivo scorgo le ultime case di Metamauco, la piccola chiesa e un lato del campanile. Mi sporgo per vedere meglio. È il campanile che mi incuriosisce. La sua mole è inconsueta, possente. Riesco a identificare anche i minimi particolari della struttura, le pietre antiche, gli anfratti creati dal tempo, quasi un teleobiettivo avesse portato la sua immagine a pochi metri di distanza. La cima del campanile è sovrastata da una massiccia croce di ferro. La croce sembra animata, una sorta di brulichio la pervade. Poi mi accorgo che i due bracci sono affollati di gente, chi sta seduto, chi in piedi, tutti accalcati gli uni sugli altri. Ci sono famiglie intere, bambini tenuti per mano o stretti in braccio o alzati sulle spalle. Altra gente, uscita dalla cella campanaria, sta arrampicandosi lungo la cuspide per raggiungere la croce. Uomini aiutano le loro donne, bambini vengono passati di mano in mano. Non capisco la loro insistenza nel voler salire dal momento che sulla croce non c’è più spazio. Penso anche al pericolo che quella gente corre nell’affollarsi in luogo così precario, ma è un pensiero distaccato. Strano che non sia già crollato tutto. E mentre questa possibilità mi attraversa la mente, vedo un uomo in piedi all’estremità della croce agitare le braccia e quindi cadere, sùbito seguìto da altre quattro o cinque persone. Le figure precipitano sgranandosi contro il chiaro del cielo, vedo nitidamente bambini che caprioleggiano nel vuoto, gonne svolazzanti, braccia e gambe che si muovono, ma non è un vero precipitare, è piuttosto uno scendere veleggiando, tanto che i movimenti possono essere prima pensati e poi realizzati apparendo così del tutto privi di quell’agitazione caotica che deriva dalla consapevolezza di vivere gli ultimi istanti di vita, non c’è quindi difficoltà nel passare con naturalezza un bambino dalle mani della madre a quelle di chi sta cadendo a pochi metri sopra di lei.
Come i primi corpi si avvicinano al suolo, altra gente cade dai bracci della croce, e lo spazio lasciato libero viene subito occupato da altri che provengono dalla cella campanaria.
Durante il volo i corpi modificano la traiettoria lasciandosi comandare dal vento. Alcuni toccano terra in Piazza della Chiesa, altri in Piazza Maggiore, altri scompaiono al di là delle case. Qualcuno viene addirittura trasportato sopra la macchia e, per evitare di scendere proprio in mezzo ai rovi, agita le braccia per portarsi più lontano, sopra i murazzi o sul camminamento. Il vento dissemina i corpi un po’ ovunque nel raggio di qualche centinaio di metri. Una volta a terra, ognuno riprende l’attività che sembra essere stata interrotta. In pochi minuti il paesaggio è animato. Per la prima volta vedo i murazzi come avevo immaginato di trovarli; adesso lungo il camminamento c’è gente che passeggia o sta seduta sul muretto a guardare il mare, molti si sono messi a pescare. Lontano, il vecchio in tuta blu elettrico a strisce gialle continua a percorrere di corsa sempre lo stesso tratto.
Rivedo il blocco di pietra con il cerchio nero. Più in là, in direzione di Lido, rintraccio anche la pietra con la barra verticale. Altri segni neri appaiono tra l’uno e l’altro, altri sono proprio sotto di me e altri ancora in direzione di Alberoni. Mi risulta facile adesso collegarli tra loro e leggere la frase che compongono: CI SONO SEGNALI.
È stato il matto a dire quella frase. Mi giro. Fosca e Ianù sembrano in attesa delle mie domande.
– Quali sono i segnali? – Chiedo.
È Ianù a rispondere: – Basta guardarsi intorno, essere informati. Grandi eventi e particolari minimi, da sbadigliare senza mettere la mano davanti alla bocca o pulirsi il naso in pubblico fino alla distruzione delle radici culturali e alla vita trasformata in carosello pubblicitario, tutte realtà che conosci benissimo, basta collegarle in un unico disegno.
– Aggressività e arroganza come chiavi di successo – adesso è Fosca a parlare. – La parola sostituita dal grido, il bacio dal morso, l’amore dallo stupro, trasgredire ogni moralità per ottenere audience ed erigere lo scandalo a marchio di potere. – Sorride, e il suo sorriso mi ricorda quello di Ottavia. Mi accarezza, la sua mano scende dal viso al petto e poi scende ancora e mi preme sull’inguine. Il mio corpo risponde. E mentre Fosca continua a manipolare e massaggiare, Ianù si appoggia con le spalle alla parete, alza lentamente la gonna, si passa una mano tra le cosce e comincia a masturbarsi.
Il volto di Fosca è di fronte a me, la sua espressione è ironica. Appoggiata alla parete, Ianù mugola per il piacere che si sta procurando. Uso tutte le forze di cui ancora dispongo per strappare gli ultimi veli. Vedo il volto di Fosca trasformarsi, i suoi capelli si allungano… adesso c’è Ottavia di fronte a me. Ancora scaglie da eliminare, ancora pelle da rovesciare. Rivolgo lo sguardo a Ianù. Le sue palpebre sono appesantite dal godimento raggiunto. Si porta le mani dietro la schiena, slaccia il nastro che le tiene raccolti i capelli e questi si sciolgono e la luce che entra dalla finestra li trasforma. Quando hanno finito di arricciarsi e di schiarirsi in un biondo dorato, anche volto e corpo sono quelli di Sala.
– Cominci a capire adesso? – Mi chiede Ianù con la voce di Sala.
– Modelli di vita, standard sui quali omologarsi. – Dice Fosca con la voce di Ottavia.
– Ormai è un processo irreversibile, Anzio – incalza Ianù-Sala. – Ci sono segnali inequivocabili per chi è in grado di interpretarli. Sono la conferma che non si può più tornare indietro. Gli angeli stanno cadendo a grappoli e il loro sesso è diventato palese.
– Chi sei… chi siete veramente?
– Tua madre. – Risponde Ianù tornata all’improvviso sé stessa.
– Tua sorella. – Risponde Fosca riprendendo le usuali sembianze.
– Eri tu nel bunker con Pauli – dico a Ianù. – Sei stata tu a ucciderlo. Ho visto quando lo hai pugnalato alla schiena.
– Lo so. Avrai anche visto che l’ho ucciso mentre stava riversando il suo seme dentro di me. È essenziale catturare l’attimo per ottenere elementi validi. – Ianù si accarezza il ventre. – Tra nove mesi avrai un altro fratello, Anzio, e sarà uno di noi. Per poter portare avanti il progetto è necessario essere nati dalla morte. Per Pauli la morte sono stata io. Solo mettendo incinta la morte possiamo moltiplicarci, solo quando una di noi riceve il seme da un cadavere potrà partorire un nostro simile. Pauli, quando ha finito di fecondarmi, era già un cadavere.
Per quanto ormai sia a un passo dal fare il balzo in questa nuova realtà, le parole di Ianù mi stordiscono. Le due donne sono in piedi di fronte a me, sono qui apposta per condurmi per mano. Devo abbandonarmi completamente a loro. Sento gocce di sudore che mi solleticano la fronte. – Quand’ero piccolo chiedevo di mio padre… Blanco, era questo il suo nome. Però hai detto che non è morto.
– Infatti. Ma Blanco non è tuo padre. Avrebbe potuto esserlo, però, nel momento in cui l’ho avuto dentro di me la mia azione non è stata mortale. In qualche modo è sopravvissuto ed è riuscito a districarsi dal labirinto di gallerie che unisce il sistema dei bunker dove vengono abbandonati i corpi ormai inutili. Abbiamo notizie di qualche altro caso. Potremmo eliminarli ma non ne vale la pena, sono ormai innocui, poveri pazzi a cui nessuno dà credito.
– Un uomo che si chiama Blanco vive in un ospizio qui a Lido. Un vecchio mi ha parlato di lui, di questa torre… e dei segnali.
– Sì, è tutta gente uscita male dall’esperienza. Cercano di mettere in guardia il mondo attraverso i loro messaggi.
– Chi è allora mio padre?
– Che importanza ha? Importante è che il seme che ti ha generato abbia aggiunto un frutto alla nostra pianta. Ora ti aspetta un compito, Anzio. Contiamo molto su di te.
 La mia domanda è muta. Ianù si stringe nelle spalle: – Ti chiediamo solo di vivere in questo mondo che stiamo modificando generazione dopo generazione, assimilandoti a esso il più profondamente possibile e dando il massimo affinché continui a seguire questa direzione. Ovviamente dovrai emarginare coloro che pensano, che intuiscono cosa sta dietro la facciata. Non sarà difficile, al punto in cui siamo arrivati l’inerzia è inarrestabile. Sì, mio caro, stiamo vincendo su tutta la linea.
La mia domanda è muta. Ianù si stringe nelle spalle: – Ti chiediamo solo di vivere in questo mondo che stiamo modificando generazione dopo generazione, assimilandoti a esso il più profondamente possibile e dando il massimo affinché continui a seguire questa direzione. Ovviamente dovrai emarginare coloro che pensano, che intuiscono cosa sta dietro la facciata. Non sarà difficile, al punto in cui siamo arrivati l’inerzia è inarrestabile. Sì, mio caro, stiamo vincendo su tutta la linea.
– E alla fine che succederà?
– Non ci interessa. Il compito che ci è stato affidato è solo quello di preparare il terreno.
I nostri sguardi si incrociano… Fosca… Ianù… Anzio… le ultime scaglie cadono frusciando, l’ultimo lembo di pelle si rovescia come un guanto, adesso so di essere io, completamente, felicemente. Scoppio a ridere e allargo le braccia. Le due donne entrano nel mio abbraccio, siamo un’unica entità e, a nostra volta, facciamo parte di un’entità immensa. L’uomo nuovo è all’orizzonte.
– Ma tu – dico a Fosca. – Perché mi hai fatto impazzire di sesso nel bunker, io non appartengo a coloro che devono essere sacrificati.
Fosca scrolla le spalle. – L’ho fatto perché mi andava di farlo e perché ero più forte di te. È una delle regole basilari del nuovo ordine, ricordalo.
Ianù richiude le imposte.
La luce nella stanza rimane inalterata.
Ha pubblicato oltre un centinaio di opere fra romanzi, racconti e saggi. I suoi libri sono stati tradotti nelle principali lingue europee. Al suo attivo ha inoltre esperienze come pittore e soggettista radiofonico e televisivo. Su un suo racconto di fantascienza, Una notte di 21 ore, è basato il film Terrore nello spazio di Mario Bava (1965).



 Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "
Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "