Questa raccolta di racconti si intitola I ciechi e le stelle e mi è stata segnalata a suo tempo dalla compianta Manuela Menci: con lei e con il marito Vanni Mongini abbiamo lanciato il progetto Cose da Altri Mondi.
Questo racconto è il primo della raccolta e ci è piaciuto proporlo come una curiosità davvero rara: una novella di uno dei primi scrittori italiani che facevano fantascienza già nel 1931. Il libro è stato infatti pubblicato un anno prima dell’incredibile e romanzesca morte dello scrittore.
Sì, parrà impossibile, ma era proprio proibito a Ninì e Lulù, entrare nella biblioteca; come nei giorni prima di Natale, quando si prepara l’albero e i bambini non possono vedere. La mamma vigilava affinché il divieto fosse rispettato. Papà non doveva essere disturbato. Che cosa faceva? Certo qualcuna di quelle cose molto importanti che i bambini non devono sapere. Sicché, quando la mamma li chiamò, ed essi poterono irrompere nella stanza, si guardarono intorno, prima un po’ meravigliati e poi, forse, un po’ delusi. Non c’era nulla di nuovo; né alberi con le stelline di similoro, né giocattoli. Libri come sempre, soltanto, dappertutto; e il babbo; il quale si alzò, e li abbracciò come se fosse tornato da un lungo viaggio.
Da un lunghissimo viaggio tornava davvero, papà. Da un viaggio attraverso paesi sconosciuti, inesplorati, vergini; dove la terra cela mille insidie, il piede affonda improvvisamente, s’aprono voragini, si parano dinanzi montagne che sembrano insormontabili e che pur bisogna affrontare e superare, se si vuol raggiungere quel misterioso al di là che racchiude il premio d’altre promesse.
Si cammina a piedi, in quelle regioni, un passo dopo l’altro; e i passi si chiamano numeri; e se qualche mezzo di trasporto permette il valico d’un torrente o d’un burrone, è uno strano veicolo indigeno che ha nome «formula», e, a vederlo, non ci si immaginerebbe mai il suo ufficio.
Ninì e Lulù non potevano capire; Luisa non poteva capire; neanche il professor Fratta, con tutta la sua sapienza, poteva capire. Il regno che Alvise aveva esplorato è chiuso, circondato da un aspro reticolato di filo spinato, irto d’aculei. Bisogna che le mani abbiano sanguinato, che la pelle sia stata lacerata da quelle punte acute e spietate.
Si può assaporare una suonata senza conoscere il contrappunto, gustare un quadro senza aver mai preso in mano un pennello, esaltarsi ad un carme senza conoscere la prosodìa; ma l’eleganza di uno sviluppo in serie, la chiusa armonia d’un determinante, la snellezza di un metodo d’integrazione, sono fiori d’un orto chiuso per i non iniziati.
Il vivente Beethoven della matematica non avrà mai l’incenso e la mirra ch’ebbe l’Einstein della musica; o glieli offriranno in cuor loro gli sperduti re magi di un popolo senza templi né riti; ché disgraziatamente — o per buona sorte? — quelle bellezze, ignote ai laici, sono quasi ignote ai chierici medesimi di quell’arte.
Da un lunghissimo viaggio. Ora, lieto, assaporava il thè tra la moglie, felice di quella gioia come il pianeta è felice della luce del sole, e i figli, che folleggiavano rincorrendosi. E il suo riposo era quello del troglodita dopo la lotta vittoriosa. I millenni non avevano cambiato se non l’avversario e la posta del combattimento. La moglie i figli la gioia erano uguali.
***
Accoccolata sul tappeto, gli occhi in su, Luisa fantasticava.
Certo egli la amava; certo ella poteva esserne orgogliosa e felice. Anche fra le sue amiche, antiche e recenti, nessuna poteva vantare un marito così fedele e sapiente. Il più piccolo malcontento sarebbe stato ingiusto e crudele. Alvise era perfetto. Certe sue assenze, certe distrazioni, non potevano proprio essergli rimproverate. Erano il rovescio insignificante di una medaglia… quale medaglia! Poi, l’uomo è fatto così. Il migliore degli uomini, il più affezionato e caro, non può essere tutto di una donna. Una donna non può riempire di sé tutta, proprio tutta una mente che non sia, di per sé, deserta. Certo sarebbe più bello. Forse gli uomini non possono capirlo; oppure è proprio necessario che sia così. Tuttavia…
Afferrò Ninì che passava correndo, l’avvicinò a sé, le rifece il fiocchetto azzurro che le fermava un ricciolo.
— Questi bambini cadranno e si faranno male! — esclamò. — Sei stanco? Hai caldo? Vuoi che apra la finestra della veranda?
— Volevi sapere quel che stessi facendo? — disse Alvise. — Ma bada, sai, devi fare bene attenzione!
— Eccomi tutta ad ascoltare. Anzi, aspetta.
Si alzò, andò ad ammonire i piccoli che non corressero troppo, che non facessero gli sventati, che non entrassero a disturbare; poi tornò accanto al marito, e s’accomodò sui cuscini per ascoltare.
— Sai che cosa sono gli atomi? — cominciò Alvise.
— Sì — disse Luisa, franca. — Sono cosini piccini piccini, che non si possono tagliare.
— Brava. Orbene, la fisica attuale, pur non essendo ancora (o non essendo già più) in grado di dare una rappresentazione degli atomi, ammette che essi siano a loro volta composti di cariche elettriche corpuscolari. Tutto ciò che esiste è dunque formato di corpuscoli elementari, variamente raggruppati… Mi segui?
— …Variamente raggruppati. Allora non è più vero che gli atomi siano indivisibili?
— Sì e no. Si possono dividere, ma allora perdono il loro carattere di «particelle di materia». I corpuscoli, le «cariche elementari» di cui sono formati, non sono già più «materia». Sono un qualche cosa che la nostra mente non può immaginare. Costituiscono l’Universo.
— L’universo? — esclamò Luisa. — L’universo è costituito da cose che la nostra mentre non può immaginare?
— Pensa ad un selvaggio che veda per la prima volta la nebbia. Si formerà un certo concetto della nebbia, ma con la sua mente ottusa non capirà mai come essa sia fatta. Così siamo noi di fronte alla materia. La vediamo ma non possiamo capire di che cosa sia fatta. Fino all’atomo ci arriviamo. Al di là dell’atomo, mistero.
— Anche per te?
— Per tutti. Si è riusciti però a sapere molte cose, sul conto di quei corpuscoli indefinibili. Essi possono combinarsi e separarsi. Nel primo dei casi, quando si uniscono, sprigionano una certa quantità di energia. Questa energia è prodigiosamente grande. L’uomo non è mai riuscito ad utilizzarla, perché — attenta bene — perché non è mai riuscito sinora a provocare artificialmente (eccetto che nel campo ristretto della radioattività) le metamorfosi atomiche che sono necessarie per liberarla; per farla uscire. Hai capito?
— E tu… hai potuto?
— Io ho semplicemente trovato che la probabilità che l’inizio di uno di questi processi di metamorfosi abbia luogo è massima quando sono realizzate certe determinate condizioni. In parole povere ho trovato la via buona per giungere a provocare artificialmente lo sviluppo delle sterminate quantità di energia racchiuse nella materia.
Muta, scivolando a poco a poco lungo il fianco della poltrona, Luisa s’era ripiegata su sé stessa, e lo guardava. — V’è un uomo in questo momento nel mondo, — pensava — che ha una sua grande scoperta da annunciare, e quest’uomo è mio marito, e parla a me prima che a chiunque. — Che importava non comprendere tutto? Certo sarebbe stato preferibile, ma forse meno bello! Strinse forte la mano di Alvise, che le cingeva il collo, e la portò alle labbra.
— È una cosa molto importante, vero? — mormorò.
— Sì. Quest’energia è tale — rispose Alvise levando gli occhi al soffitto — che quella sviluppata dalle più energiche combinazioni chimiche è, al confronto, un giuoco di fanciulli. Vedi questa sigaretta? Pesa un grammo. Un grammo di materia. Se tutta l’energia interatomica che questa materia contiene potesse essere sviluppata, se ne ricaverebbero… se ne ricaverebbero, in un’ora, trentaquattro milioni di cavalli.
Trentaquattro milioni di cavalli! Sì, Luisa comprendeva benissimo. Trentaquattro milioni in una sigaretta, dieci volte tanto nel pacchetto! Cifre astronomiche, immense, inimmaginabili… Capiva, sì…
— E potrai fare questo? Potrai liberare questa energia?
— Credo di sì, qui, in questa stessa stanza, sotto i tuoi occhi. Gli esperimenti li farò al laboratorio, s’intende. Ma mi serviranno soltanto al lavoro preparatorio, per trovare una certa soluzione colloidale che è indispensabile. Il resto non richiederà che un raggio di luce.
— Ma, e tutta questa energia? Salteremo in aria?
— Sarà assorbita, in questa prima prova, non temere, da un’altra trasformazione parallela. Quel che mi preme, per ora, è solo controllare l’esattezza dei miei calcoli. Se il processo di trasformazione potrà essere iniziato, solo iniziato per un attimo, basta. Il mio scopo sarà raggiunto. Il mio metodo di analisi matematica riceverà il più clamoroso dei battesimi. Ora, cara Isa, finisco alcuni particolari, e poi, al lavoro!
— Al lavoro? Ma non è finito, il lavoro?
— Finita la teoria. Ora bisogna trovare sperimentalmente, caso per caso, i valori dei parametri che… insomma controllare uno per uno i singoli casi i quali, per così dire, rendono possibile il fenomeno che voglio provocare. Perciò, mentre il lavoro di concetto è terminato, mi rimane da svolgere la parte sperimentale. E ci vorrà parecchio.
— Molti giorni ancora?
— Giorni? Molti mesi! Anni, forse.
— Ma quanti sono questi casi da verificare?
— Oh, sono circa sessantamila! — rispose Alvise scorrendo con l’occhio i suoi appunti. Sessantamila ottocento sei, — precisò; — di cui due da escludere perché uguagliano a zero tutte le radici. — E, chiuso il quaderno, guardò Isa con l’aria beata dell’uomo soddisfatto di sé, del mondo, e delle cose.
Ma che cosa accadeva laggiù fra Nini e Lulù? Un piccolo conflitto che, chi sa, senza l’intervento di un potente neutrale avrebbe potuto avere serie conseguenze per i capelli di Nina. E Isa dovette correre a metter pace.
— Che amori! — pensò appena, sedata la tempesta, li vide tornare, buoni, al loro gioco — Dimmi, Alvise, non è più bello un bambino di tutta la matematica del mondo?
— È un’altra cosa — rispose Alvise per tenersi sulle generali. — Non si può istituire un paragone fra eterogenei.
— Ma guardali! — insisté Luisa — Che cosa ci può essere di più bello al mondo? Tutto quello che fanno è puro, innocente, senza malizia, senza cattiveria… È bello! È grande!
— Ma… tu sei la mamma — arrischiò timidamente Alvise.
— E tu? Non sei il padre, tu, cattivaccio? Non sei il padre?
— Sì, ma…
— E allora devi capirli anche tu!
— Io li capisco, ma…
— Zitto! Devi capirli senza capire! Hai capito?
Risero entrambi come fanciulli, baciandosi. Poi egli tornò al suo eterno lavoro, ed ella rimase lì, ad adorare.
***
«Non verrà a capo di nulla».
Le parole del professor Fratta le risuonavano all’orecchio, fastidiose, come uno scampanìo che si attenui o ravvivi col vento, ma che, anche fievole, rimanga sempre presente, fra sensazione e ricordo.
Non verrà a capo di nulla. Perché? Quale autorità, quale competenza poteva avere il professor Fratta, ordinario di istituzioni e diritto, in quella materia? Nessuna; ed ella lo sapeva. Solo un buon senso maccheronico gliele aveva ispirate. Il buon senso statistico di chi, constatando che una mosca sola, su centomila, è bianca, sentenzia, di una mosca che non vede: essa è certamente nera. Giustissimo; in novantamila novecento e novantanove casi.
Ma quello di Alvise era veramente il centomillesimo? Da quattordici mesi egli si ostinava a cercare la sua famosa soluzione colloidale. Le soluzioni colloidali sono intrugli gelatinosi, composti di svariati ingredienti; questo ella sapeva. Se ne possono comporre infinite, variando ingredienti e proporzioni. Quale guida aveva Alvise nelle sue ricerche? Nessuna. Doveva affidarsi — l’aveva ripetuto tante volte — al caso. In quattordici mesi aveva eseguite poco più che ottocento prove; tutte, naturalmente, con esito negativo. Per conseguire questi magri risultati, egli si era sobbarcato ad un lavoro massacrante. Le lezioni che pur doveva continuar a tenere, gli assorbivano gran parte della giornata; si dedicava alle sue ricerche nelle ore libere, e la sera.
La sera! Quattordici mesi che, quasi senza eccezione, Alvise rincasava a mezzanotte, all’una, sempre più pallido, sempre più stanco. Non era crucciato, no. Si manteneva sereno ed affettuoso con lei quanto potevano permetterlo la sua salute che deperiva, e l’ansia che lo tormentava di coronare con un risultato tangibile la sua fatica. «Un giorno mi vedrai tornare con vele bianche» diceva. «Quel giorno ci compenserà di tutto ciò che abbiamo sofferto». Diceva: «abbiamo»; avrebbe dovuto dire: «hai». Per lui il lavoro era la vita, la ragion d’essere. Lavorando s’astraeva e dimenticava. Per lei no, quella snervante attesa non era «vita». I bambini erano un gran conforto, certo; ma i bambini possono colmare tutte le lacune, per una donna, tranne una. Se si fosse trattato di un sacrificio a termine certo, ben definito, lo avrebbe sopportato volentieri; ma chi poteva prevedere la fine di quello stato di cose? E se una fine non fosse più venuta? Se quell’odioso professor Fratta avesse avuto ragione? Se Alvise non avesse potuto venir a capo di nulla? Anche quella sera, come tante altre, la mezzanotte era già scoccata. Quando sarebbe rientrato? Ella si alzò e, in punta di piedi, si recò nella stanza dei bambini. I due lettucci affiancati, sembravano leggerissimamente animarsi al ritmo dei due respiri. Tutto era immobile, eppure qualche cosa di ineffabile, di inconfondibile, testimoniava, contro ogni apparenza, della vita. La penombra della stanza n’era riempita. E quello le parve il mistero, il divino mistero che nessuno scienziato avrebbe mai penetrato; e nessuna «sostanza colloidale» ne avrebbe racchiuso uno di più grande e più bello.
Alvise rincasò a notte alta, reggendo a stento una grossa cassetta di legno, sfatto dalla fatica e dalla commozione, e raggiante. Aveva trovato.
***
La sostanza pareva chiaro d’uovo, ma più limpida, quasi brillante; e riempiva per tre quarti un gran vaso di cristallo, col fondo traversato da due sottili tubicini all’estremità dei quali erano due piastrine lucenti. Il vaso posava sopra una specie di tripode, che doveva racchiudere nella sua base qualche delicato strumento elettrico, a giudicare da alcuni piccoli quadranti provvisti di indici. L’insieme poteva essere introdotto in una custodia ermetica, il cui coperchio, levigatissimo, pareva di marmo nero.
— Questo è tutto — disse alfine Alvise quando ebbe verificato che ogni cosa fosse intatta. — Come vedi, è molto semplice.
— Questo è l’apparecchio? Questa è la macchina? E va? Va bene? La butterò dalla finestra, sai, se non ci darà tanta gioia per quanto ci ha fatto soffrire!
— Guardatene bene! — rispose Alvise ridendo. — Non ho ancora eseguita l’analisi completa, e se perdessi quel che è contenuto in questo bicchiere dovrei cominciare tutto da capo. Allora sì, povera Isa!
— Mettine subito da parte un pochino, allora! — esclamò Isa. — Se il vaso cadesse e si rompesse, come faresti? Vuoi proprio farmi morire di ansia?
— Lo farò, non temere! Vedi, intanto? Per scovare questa dannata composizione, ch’è una proteina disciolta, sono ammattito per quattordici mesi. Ma credi che sia stato sfortunato? Neppure per idea! La teoria delle probabilità mi assegnava un termine approssimativo, dato il ritmo del mio lavoro, di quasi cento anni. Sei contenta?
— Mio Dio! E avresti avuto il coraggio di continuare così per… cento anni?
— Sono stato un pazzo, Isa, lo so! Ma, vedi, ero stato ispirato. Ora non pensiamo più al passato, Isa. Ci si apre davanti un avvenire quale forse non avremmo mai sperato. Una energia praticamente infinita è qui, nelle mie mani, sotto questo coperchio di pergamena. Sembra olio di ricino, guarda!
— Che cosa farai? Come farai?
— Tutto è pronto, Isa! La casa era preparata per ricevere l’ospite sin dall’anno scorso. Ricordi i miei studi sui cristalli? Ricordi quanta importanza attribuissi ad essi? Bene, ascolta. La liberazione dell’energia contenuta in questo liquido non può avvenire che per effetto di onde immensamente piccole. Tu sai, Isa. Il suono, l’elettricità, il calore, la luce, i raggi x, tutte vibrazioni sempre più rapide e sottili, sempre più lontane dai nostri mezzi di investigazione. E al di là delle più sottili, sai che ve ne sono ancora altre, quelle che i fisici hanno chiamato «radiazioni penetranti». Onde così brevi e rapide che traversano qualunque sostanza, ogni ostacolo; e giungono alla Terra dopo aver percorso non gli spazi limitati del nostro sistema stellare, ma quelli inimmaginabili che ci separano dalle nebulose spirali. Distanze che si misurano a milioni di anni luce… Bene, queste radiazioni accenderanno il processo di disintegrazione atomica di questa piccola massa inerte. Guarda il coperchio della custodia. Sembra marmo. È un cristallo raro, un cristallo sintetico che io stesso ho creato quando ho potuto penetrare la legge di formazione dei piani reticolari… Ricordi? Questo cristallo è la sola sostanza al mondo che sia capace di far convergere le radiazioni penetranti allo stesso modo che una lente fa convergere i raggi luminosi.
— Sei un mago, Alvise! — interruppe Luisa guardandolo con infinita venerazione. — Io, debbo chiederti perdono, se mi sono mostrata impaziente, insofferente. È perché non so… non sapevo…
— Tutto è nulla, Isa, tutto è nulla, se le cose «andranno». Ora, vedi, quei due tubicini che escono dal fondo del recipiente, sono collegati ad un indicatore termoelettrico di estrema sensibilità. Esso ci permetterà di accorgerci immediatamente del fenomeno, appena avrà avuto inizio. Se il composto non assorbisse, poi, tutta l’energia, man mano che si sviluppa…
— Ebbene?
— Non ci rimarrebbe il tempo di addolorarcene, e neppure di dire: oh! Tu, ed io, e questa casa, e cento altre intorno, tutto rimarrebbe volatilizzato all’istante; se pure il fenomeno, una volta innescato, non continuasse fino ad incenerire il mondo intero… Scherzo, sai. Prima di tutto ciò non accadrà. E poi, vedi, c’è l’indicatore; che fa da allarme. Non aver paura. L’occhio soltanto, rileverà un cambiamento di colore, dovuto alle reazioni di assorbimento interno. Attenta.
Rimise il vaso sul suo piedestallo, poi, lentamente, con precauzione, introdusse il tutto nella custodia, sotto la lastra di cristallo che avrebbe operato il prodigio.
***
Non poteva, non poteva continuare così!
La sostanza, le radiazioni, l’energia… Che importava a lei? Che importava a lei? Il suo Alvise, il suo amore, impazziva per quelle idee troppo grandi, per quelle cose troppo difficili. Ella non contava più niente; i bambini neppure. Lo vedeva, lo capiva! Il «suo» mondo era quello: un mondo di astrazioni e di idee, fredde, aride, lontane dal cuore. Ecco che il mancato realizzarsi di una previsione scientifica lo straniava dalla vita e dagli affetti, lo allontanava da lei, dai figli, da tutto. Aveva ragione il professor Fratta! Aveva ragione il professor Fratta!
S’asciugò gli occhi, cercò di ricomporsi, cercò ancora una volta di farsi forza. Alvise era entrato, s’era seduto alla tavola, gli occhi fissi ed intenti all’apparecchio, la testa fra le palme.
— Quello che mi dà le vertigini è non capire! — esclamò. — Se nulla fosse accaduto, se questa maledetta sostanza fosse rimata quieta, pazienza! Avrei pensato di aver fatto male qualche calcolo, di essere stato un po’ precipitoso nelle mie conclusioni. Ma qui sono successe cose inesplicabili. Perché la superficie superiore del miscuglio s’è ingobbata verso l’alto? Perché? Non c’è coagulazione, non ci sono variazioni di densità, né di proprietà chimiche. Da ieri ho fatto tre saggi di verifica. Il fluido è perfettamente omogeneo, come quando l’ho messo nel suo bicchiere. Che cos’è questo indovinello? Da quando in qua un fluido non si dispone secondo una superficie di livello?
— Amore mio, perché affaticarti così? Perché tormentarti? Tutto ciò che non comprendi a prima vista, lo sai, lo sai bene, si chiarisce sempre poi, con un po’ di tempo e un po’ di pazienza. Vuoi ammalarti? Ammalarti ora che stai per raccogliere il frutto della tua fatica?
— Ma non capisci che questo è un fatto contrario alla legge di gravità? Hai mai visto un fiume scorrere dalla foce verso la sorgente? L’hai mai visto?
— Ragione di più per non arrabbiarsi. Qualche cosa di nuovo è appunto accaduto, e domani tu lo capirai; e la tua grande scoperta sarà cosa fatta. Non ti sembra?
— Mi sembra che batter la testa sui muri sarebbe ancora poco! — gridò Alvise. — Non mi sono spiegato dunque? Non hai capito quello che ti ho detto? Qui non ci sono radiazioni né diavolerie che tengano! Qui c’è un bicchiere con un liquido, guarda! — Tolse il vaso dal suo supporto, lo posò sulla tavola poi l’alzò contro la luce, lo inclinò un poco, lo rimise orizzontale — Una cosa liquida, o quasi liquida, perfettamente normale, fredda, senza alcun principio neppur lontano di disintegrazione interna, nella quale io posso introdurre il dito — guarda! — e che di per sé, lasciata a sé stessa, senza azioni esterne o interne, se ne sta… se ne sta… Non lo so neppur dire! Se ne sta così come tu vedi! Ma vedi anche tu che è rotonda di sopra? O sono io che ho le traveggole?
— Sì, rotonda — disse Isa tranquillamente — Ma non vedo perché tanta meraviglia, dopo tutto. Anche… Anche la pasta del pane, quando lievita, non «monta»? Sarà «montata» anche questa.
— Per carità, Isa, per carità, non dire! Non puoi, non puoi capire!
— Alvise — sussurrò Luisa dopo un lungo silenzio, appoggiandosi pian piano alla sua spalla, con tutta la dolcezza che poté — Alvise, ascoltami. È tardi, ora. Tu sei stanco. Hai tanto bisogno di riposo. Vieni a dormire. Vieni a fare un bel sonno lungo lungo, quieto quieto, senza pensare proprio a nulla. Per il tuo bene, sai, per te. Domattina ti sveglierai fresco e riposato e questi problemacci li risolverai, col tuo testone, come bere un bicchier d’acqua. Ho ragione? Ho ragione Alvise?
Egli si lasciò condurre, e poi obbedì in tutto; fuorché in una cosa; ché il pensiero non si comanda; o per saperlo comandare bisogna essere qualche cosa più che scienziati.
***
Nel tempo dei tempi, quando la Terra era appena uscita dagli sconvolgimenti della sua infanzia travagliata, il regime delle acque e dei venti, delle temperature e delle stagioni, era molto diverso da quello attuale. I geologi sono concordi, a questo proposito, nel non concordare con le ipotesi e non è colpa loro, ma del gran tempo trascorso da quei giorni ad oggi. Tutti però sanno che un giorno, presso la deserta spiaggia di un continente appena formatosi, lungo la zona umida che la marea scopriva e ricopriva ritmicamente, per la prima volta sul pianeta una cellula visse.
Fu una vita infinitamente semplice, accompagnata e illuminata da un grado di coscienza così tenue da parere nullo. Ma fra lo zero e la più piccola cifra significativa che la mente possa concepire v’è pur sempre un abisso. E quell’abisso era per la prima volta colmato.
Molti milioni di anni più tardi ciò doveva dar luogo ad un grande strepito di discussioni cortesi e scortesi tra vitalisti e non vitalisti; ma la piccola cellula non poteva pensare, fra le conseguenze, a questa. Se avesse avuto un pensiero, esso sarebbe stato: «Io mangio!». Il primo istinto, il primo embrione di affermazione era stato l’imperativo del nutrimento; e dovevano passare legioni di secoli prima che l’impulso vitale acceso in seno alle singole cellule susseguentisi senza continuità, suggerisse alla prima d’esse di sdoppiarsi per dar luogo, con la prima gemmazione, alla prima forma di conservazione della «specie».
Ma il Sole, il grande motore che aveva attivate tutte le energie terrestri, era estraneo al prodigio. Questo gigantesco operaio d’ogni lavoro della Terra, questo infaticato artiere che alimenta tutte le vite e ne regge il corso e le vicende, non racchiudeva nei suoi raggi la virtù creativa che fa scaturire la vita dalla non vita.
Erano esse, le infinitamente piccole radiazioni, che l’avevano portata di lassù, dagli universi ultra-stellari, messaggere di un segreto che deve essere sussurrato a tutte le città della gran patria celeste.
***
E subito, non appena Alvise aveva posto il liquido sotto il cristallo, le messaggere s’erano messe all’opera.
Nella massa fluida e bianchiccia, concentrate dal cristallo, erano confluite a torrenti, inesauribili ed inesauste, dopo i millenni di un viaggio tra gli spazi eseguito con la velocità della luce. Così sottili da poter attraversare uno spessore di molti metri di piombo prima di essere arrestate, scorrevano a fiotti lungo gli interstizi tra le molecole della proteina contenuta nel bicchiere, s’insinuavano entro la compagine delle molecole medesime, come un getto d’acqua attraverso gli àcini di un fitto grappolo di uva; s’infiltravano entro le connessure stesse degli atomi più complessi, traversandone milioni senza indebolirsene.
Quale ostacolo rappresentava quell’oncia di materia al loro impeto? Nulla; il velo di una rete tesa attraverso un’impetuosa corrente. Ma, concentrate dal cristallo, converse tutte verso un punto centrale di quella massa fluida, la loro energia vibratoria era costretta a comunicarsi in parte a quella materia, che n’era frugata e forzata; ed era come se impercettibili brividi trascorressero per la massa biancastra; brividi di ampiezza inapprezzabile per noi, brividi che scuotevano gli infimi granuli costitutivi di quella materia.
E a poco a poco il miracolo avvenne; né il suo processo può essere descritto con parola del macrocosmo; cariche elettriche, elettroni, quanti, ciò che il linguaggio umano ha fissato entro i termini di una definizione e ciò che non vi ha potuto ancor costringere, gli elementi che giocano la gran partita dell’universo, conversero a poco a poco la ridda dei loro movimenti in un ordinato susseguirsi di oscillazioni, non più obbedienti alla sola legge del caso, ma armoniche, legate ormai l’una all’altra da una legge comune; e come milioni di anni prima spontaneamente, così per la prima volta per artificio di uomo, la materia accolse il messaggio.
Non era l’effetto che Alvise aveva preveduto ed atteso. Era un’altra cosa, ancor più meravigliosa ed augusta.
***
Il letto aveva già accolto Alvise insonne quando il primo visibile fremito aveva fatto palpitare la morta soluzione prigioniera del vetro; e solo l’oscurità e il silenzio erano stati testimoni del prodigio. Ora, dopo una giornata che era stata di vano tormento per lo scienziato e di trepida angoscia per la sua compagna, un’altra notte era calata sul mondo; e una creatura ormai nata, ormai vitale, lottava già per obbedire ai fini misteriosi che la vita comanda.
Quella che era stata una pozza liquida entro un recipiente, era divenuta durante la seconda notte una forma ovoidale, gelatinosa, non più avida di aderire alle pareti secondo la formula bruta del peso, ma anelante di stringersi intorno ad un nucleo centrale.
Ma il modo desueto del risveglio, e le particolari qualità della sostanza proteica che Alvise aveva inconsciamente scelto, avevano dato origine al sorgere di una creatura infinitamente più complessa di una cellula primigenia. Era un essere mostruoso, ma complicato e, in un certo orribile senso, perfetto; una genitura ibrida che non poteva appartenere ad alcuna famiglia di individui terrestri, ma non aveva neppure la elementare struttura di un protozoo.
L’opera dell’uomo aveva fatto nascere un essere fuori d’ogni legge, fuori d’ogni realtà; gli aveva acceso dentro un formidabile, sproporzionato fuoco di vita, aveva osato sostituirsi al destino nel compito dell’evoluzione. In seno al magma argenteo un punto più scuro, impercettibile dapprima, poi man mano più distinto, si formò a poco a poco; si ingrandì, s’addensò.
Miriadi e miriadi di molecole, sciami innumerevoli d’atomi roteanti, inseguendosi, urtandosi, collidendo, perdendo e acquistando corpuscoli in tutte le direzioni, si agitavano, roteavano, turbinavano intorno a quel nucleo. Una trasformazione profonda, crescente via via con ritmo accelerato, modificava la struttura chimica delle zone circostanti; quei moti non erano casuali; obbedivano ad una entelechia, riflettevano la imperiosa necessità che assegna ad ogni essere organi e funzioni.
All’alba, la massa aveva quasi finito d’obbedire al richiamo. Una specie di incudine molliccia, trasparente e madreperlacea, come una strana medusa, sorgeva già dal bicchiere. Tre estremità tondeggianti, a tripode, poggiavano ancora sul fondo, ma già il corpo si era assottigliato, e i due tronconi superiori traboccavano dall’orlo. Un lentissimo movimento, come di verme che tenti la via innanzi a sé, li animava. Al vertice di uno di questi tronconi, un’iridescenza balenava a tratti, rapidissima, come quelle che lampeggiano sulla superficie nuda di un acciaio esposto alla fiamma. Erano gli strati di molecole che incessantemente si formavano, intenti a costituire l’embrione di una testa.
Qualche ora dopo, tutta quella estremità era scura e densa come l’epitelio degli alluci nei felini. Il tripode vivente nella sua prigione di cristallo ebbe un sussulto; tutto il corpo parve divincolarsi come in uno sforzo di liberazione; oscillò un attimo sullo scrimolo dell’orlo; poi traboccò, abbattendosi pesantemente, con un piccolo tonfo sordo, sul tappeto della scrivania. La «cosa» lasciava il suo alvo per il mondo.
***
— Questa volta non mi rimprovererai d’aver dormito poco! — disse Alvise mentre si vestiva in fretta. — Avevi ragione, però! Un buon riposo fa bene, di tanto in tanto. Mi sento un altro, oggi. Perché mi guardi così? Ti meraviglia vedermi allegro?
Effetto di stanchezza, sai, il mio malumore — proseguì senza attendere la risposta. — Tossine che si accumulano; col riposo il sangue se le porta via piano piano; l’organismo si svelena e torna il sereno. Oggi sento che verrò a capo di qualche cosa. Sei contenta?
L’impulso di gridare, di trattenerlo, di dirgli subito tutta la verità mosse le labbra di Luisa, per un attimo, ma le parole non uscirono. Rimase lì, raggelata, senza respiro, ad attendere. Ecco, era entrato nello studio; si avvicinava all’apparecchio, guardava, vedeva… Sentì l’aprirsi e il richiudersi, secco, della custodia; il rumore di qualche passo concitato; poi, dopo un silenzio che parve eterno, nell’inquadratura della porta, apparve la maschera muta e sbalordita di Alvise.
Il recipiente era vuoto, la sostanza era scomparsa, ella lo sapeva già da qualche ora; dal momento in cui, appena levatasi, un’istintiva curiosità l’aveva spinta ad entrare nello studio.
Una gran nube le era scesa intorno, una specie di nebbia che le impediva di immaginare, di prevedere, di pensare. Che cosa era accaduto? Che cosa avrebbe fatto Alvise? A quali altri sconvolgimenti il nuovo fatto misterioso avrebbe condotto? Macchinalmente, come ogni giorno, aveva preparato i bambini, li aveva guardati scomparire accompagnati dalla governante lungo la solita via, verso la scuola da cui sarebbero tornati soltanto la sera; poi s’era aggirata da una stanza all’altra, di pensiero in pensiero, attendendo il risveglio di Alvise, tremando per il momento in cui egli avrebbe veduto e saputo.
Eccolo, quel momento. Era giunto. Alvise, come trasognato, dopo qualche domanda si era immerso in un mutismo cupo, in una specie di tetra rassegnazione. A che cosa pensava? Quali idee lo tormentavano? Avrebbe voluto ricominciare la via tremenda delle prove e dei tentativi? O si sarebbe accasciato sotto il peso di quel colpo? Con quali conseguenze per lui, per lei, per la loro felicità?
Le ore passarono, nere, uguali, come nell’ombra di un lutto che si fosse repentinamente addensato, senza che Alvise parlasse. Quali parole avrebbe potuto pronunciare? A che pro? Pensava; nell’immenso vuoto in cui gli pareva di essere stato ad un tratto sbalestrato, solo l’esile filo del pensiero lo ricollegava alla vita; e tesseva in silenzio, una dopo l’altra, le tele delle ipotesi più avventurate, più assurde; una dopo l’altra, le vedeva sfarsi, cedere, sgomitolarsi, ridursi a quel filo sottile con cui bisognava pur ricominciare a tessere, a tessere…
La febbre. Come un fanciullo si lasciò ricondurre al letto da cui era balzato giù poche ore prima con tanta speranza e fiducia; si lasciò accarezzare, inerte, dalle mani amorevoli di Luisa; si lasciò sommergere senza resistenza dall’onda di una smisurata stanchezza; le palpebre gli ricaddero, s’assopì. Ella uscì piano dalla stanza, si recò nello studio, si lasciò cadere sulla poltrona, anch’essa affranta da una stanchezza dolorosa.
E mentre singhiozzava sommessamente, la faccia tra le mani, la bella fronte reclinata quasi fino alle ginocchia, qualche cosa, nella penombra della sera, lampeggiò lassù, sul soffitto, agli ultimi raggi del giorno, con un riflesso argenteo. Qualche cosa di indescrivibile, di orrendo, oscillando si staccava pian piano dall’intonaco della volta, fino a che non fu più trattenuto, e cadde. Una massa grigiastra, molle, gelatinosa, le sfiorò i capelli, le strisciò lungo l’òmero, s’abbatté con un tonfo sul bracciuolo di cuoio della poltrona, poi rotolò sul pavimento, contorcendosi.
Allora nella donna esausta parve destarsi il serpente che dorme nel più profondo lago della coscienza femminile. Nel suo cuore atterrito la paura non ebbe tempo di urlare, sopraffatta dall’istinto più forte della maternità. I bambini! I bambini! Ebbe la forza di alzarsi, uscire, chiudere a chiave la porta dietro di sé. Il mostro era prigioniero; per il momento non avrebbe potuto nuocere. Ora avrebbe chiamato Alvise. Aprì la bocca per gridare; non aveva più voce; mosse un passo, cadde bocconi svenuta.
***
Che aria tiepida! Davvero l’estate incominciava a farsi sentire! Nini e Lulù, fra grandi strilli di gioia, correvano intorno alla governante, battendo rumorosamente le scarpette sul marciapiede e cercando le piccole pozzanghere, ahimè, non per scansarle, ma per farne schizzar l’acqua intorno intorno, con grande scandalo della miss, che minacciava un severissimo rapporto. Quella sera erano stati proprio cattivi. Lulù, fra l’altro, aveva raccattato un pezzo di legno, e non lo voleva assolutamente lasciare, malgrado gli ordini perentori della governante, la quale non poteva permettere che bambini per bene si comportassero come monelli di strada.
Quando giunsero sotto le finestre di casa la miss era ancora cento passi indietro e, approfittando della distanza, Ninì non si lasciava sfuggir l’occasione di voltarsi a farle le più belle boccacce del suo vasto repertorio. Ma fu distratta dalla vista di un animale strano, che si muoveva proprio sotto la finestra dello studio di papà.
— Uh! Uh! — gridò chiamando il fratellino.
— Che cosa c’è?
— Uh! Uh! — rispose Ninì — Brutto! Brutto!
Si fermarono a guardare. Era un animale certo strano, e ben buffo! Aveva tre zampe sole, così almeno pareva, e una specie di testa a cuneo, che si moveva in un modo ridicolissimo e antipatico.
— È una gallina?
— È un «lospo!»
— Un lospo? E che cosa è un lospo?
— È una rana cattiva — spiegò Lulù. Poi allungò un piedino e cercò di rovesciarlo.
Le tre estremità del mostricciattolo gli si avvinghiarono alla scarpetta come i tentacoli di un polipo.
— Uh! — gridò Lulù arrabbiato, dando una gran pedata — Cattivo!
— Sì, cattivo, cattivo! — si associò Ninì, e corse a prendere un grosso sasso per castigarlo.
— Che cosa fate là? Che cosa avete trovato? Lasciate subito stare! — gridava la miss. Ma, sì! Chi l’ascoltava?
Lulù aveva già fatto ricadere due o tre volte il suo bastone come una clava sul corpo della strana bestia; e il tessuto molle, spappolandosi sotto i colpi, lasciava trasudare un umore lattiginoso e argenteo, che rigava la polvere come una scia di lumaca.
— È una lumacca! una lumacca, guarda! — gridò Lulù alla sorellina. Ma questa, senza curarsi della spiegazione, prese la misura e, paf! lasciò cadere la pietra che aveva portato, proprio nel mezzo del corpo già mezzo sfatto.
In quella sopraggiunse, fragoroso e strombettante, un autocarro. I due bambini si scansarono; e avrebbero voluto gridare di fermarsi, che c’era una bestia cattiva ammazzata da loro, ma quando l’autocarro fu passato, non rimaneva più nulla, della bestia. Se l’era portata via, con sé, una ruota del veicolo. Per un po’ videro qualche cosa di biancastro, come un cencio avvolto, che girava con quella; poi più niente.
— Che peccato! — concluse Ninì — L’avevo proprio «massato» io!
Ma già, a questo mondo non si può mai godere il frutto della propria opera.
Nacque a Venezia il 19 marzo 1899 dall'antica famiglia veneziana dei Cicogna che annoverò fra i suoi antenati anche Pasquale Cicogna, Doge di Venezia e morì a Torino il 3 agosto 1932 a causa di un'esplosione verificatasi mentre stava lavorando alla costruzione di un motore a reazione. La sua raccolta di racconti "I ciechi e le stelle" tratta di fantascienza.

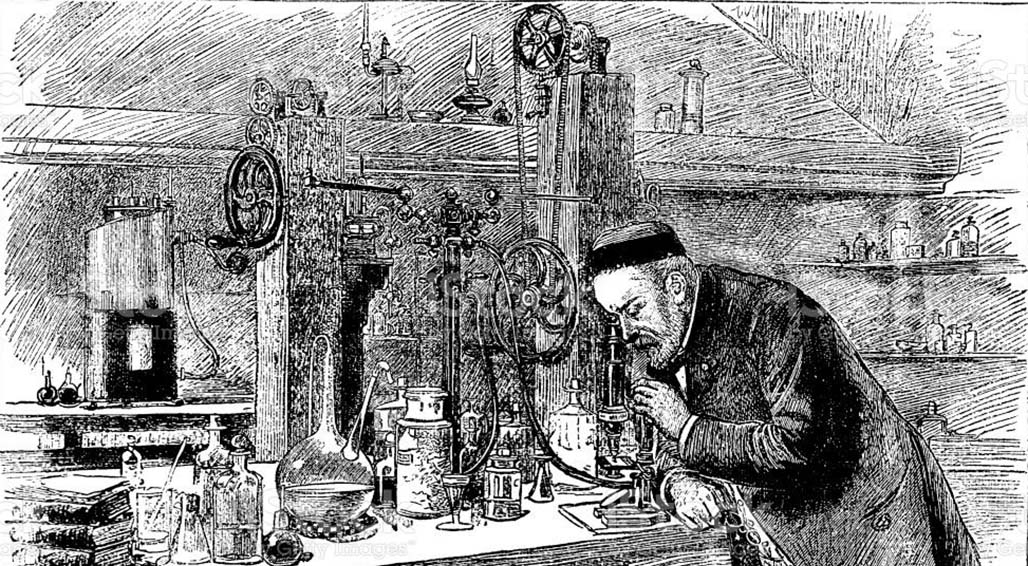

 Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "
Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "